INTRODUZIONE
Le diverse letture dello scrittore
Il II centenario della nascita di Dostoevskij è un’occasione per cercare di comprendere meglio lo scrittore difficilmente catalogabile con gli schemi di certa storia della letteratura. È anche l’occasione per rileggere testi, indubbiamente non facili, che, data la complessità delle vicende e soprattutto dei personaggi che vi si trovano, con tutti i loro tormenti interiori, possono disorientare chi vi si accosta senza una appropriata introduzione. C’è chi vi trova la vena autobiografica, che, senza alcun dubbio, permea molte pagine di quest’uomo, tanto inquieto e tanto toccato dal dolore, dal male, dallo stesso azzardo che lui ha conosciuto a partire dalla frenesia del gioco. C’è chi vi legge il tormentato ottenebramento, a cui va incontro un’Europa avviata ad un progresso industriale con l’illusione, coltivata, di poter godere del benessere, mentre invece essa scivola inevitabilmente verso una catastrofe, poi dilagata nelle tragedie del Novecento. C’è chi vi legge la ricerca spasmodica di una salvezza, tanto desiderata e nel contempo così difficilmente perseguita, mentre, con i contorcimenti psicologici che muovono verso la follia, imperversa una specie di “cupio dissolvi”, derivata dalla perdita della spiritualità, quella cristiana, a cui egli punta decisamente come la sola fonte di autentico rinnovamento.
Il pensiero dello scrittore: il senso della vita in mezzo al male
Non è facile seguire il suo pensiero, anche perché egli propriamente non è un filosofo, per quanto appaia sottesa, nei suoi testi, una certa filosofia della vita. E non è neppure un pedagogista o uno psicologo che si premura di scandagliare l’animo umano, soprattutto quando è in formazione, perché possa crescere secondo criteri ragionevoli, se non sono di fatto razionali. Egli è principalmente uno scrittore di romanzi, avendo trovato questa vena espressiva non solo come fonte di guadagno per vivere, ma come la sola modalità per lui di comprendere e spiegare il suo vissuto, estremamente tormentato, anche da una serie di circostanze drammatiche che hanno segnato la sua esistenza. Ciò che racconta sono indubbiamente vicende umane che lo sfiorano, se non altro perché molti dei suoi personaggi vivono qualcosa che appartiene alla sua stessa esistenza e riflettono mali e tormenti che lo toccano: chi ben conosce quanto egli ha vissuto, non fatica a trovare molti elementi autobiografici. E tuttavia, come succede a tanti scrittori, le sue storie sono pur sempre vicende umane, scandagliate soprattutto nel tormento interiore. Esse riflettono il parto travagliato di un umanesimo, soprattutto russo, che era in corso, in un mondo da troppo tempo in letargo e vorticosamente avviato a trasformazioni se-gnate poi dalla tragedia. Per quanto egli rifletta il mondo russo, di cui è figlio, e di cui, soprattutto, è espressione, tutto quello che scrive a proposito dell’uomo travalica comunque quel particolare mondo, e, per tanti versi, anche la sua epoca, così travagliata e sottoposta a cambiamenti, come sempre succede, non facilmente gestiti e soprattutto gestibili. Leggi tutto “Dostoevskij: una vita segnata dalla malattia, dal dolore, dal male, dalla morte”

 La celebrazione centenaria in corso deve far pensare soprattutto alla morte di Dante. È indubbiamente un evento doloroso, e, certamente, anche inaspettato, se non altro perché avviene quando il poeta, ormai famoso per la sua grande opera, avrebbe potuto godere forse qualcosa di questa sua fama. Se il cammino era posto “nel mezzo” a 35 anni, e questi suoi anni cadevano mirabilmente nel 1300, anno giubilare, ma soprattutto anno carico nei simbolismi numerici del suo totale riferimento a Dio, la vita sua si sarebbe dovuta compiere a 70 anni. Ed invece Dante sparisce a 56 anni con un tracollo che avviene in poco tempo, senza che ci siano avvisaglie. Ma questo suo inabissarsi nella morte, che tutto vorrebbe assorbire e sfiorire, diventa in realtà l’ingresso in un mondo che gli dà giustamente fama ed eternità. È quello che lui stesso avverte di meritare, pur in mezzo all’amarezza di un esilio che diventa di giorno in giorno sempre più duro e senza sbocchi. Mentre la sua situazione di esiliato si incancrenisce e addirittura si fa senza speranza con la condanna a morte, non solo sua, ma anche dei figli, dopo la battaglia di Montecatini (1315), oltre a cercare la sua pace fra chi lo ammira e lo desidera, si dedica con tutte le sue forze ad ultimare la grande opera, ormai salendo sempre più fino all’ultimo cielo. C’è dunque anche in questo suo cammino come un’aspirazione alla pace eterna, senza per questo che egli si possa augurare la morte o possa cercarla. Semmai è a Firenze che si insiste nel volere la condanna alla pena capitale. Egli piuttosto aspira al riconoscimento pubblico della sua grandezza di poeta e forse anche per questo cerca chi lo possa comprendere e sostenere in questa sua aspirazione, accogliendo l’invito del Signore di Ravenna, che ha pure interessi e sensibilità per la poesia.
La celebrazione centenaria in corso deve far pensare soprattutto alla morte di Dante. È indubbiamente un evento doloroso, e, certamente, anche inaspettato, se non altro perché avviene quando il poeta, ormai famoso per la sua grande opera, avrebbe potuto godere forse qualcosa di questa sua fama. Se il cammino era posto “nel mezzo” a 35 anni, e questi suoi anni cadevano mirabilmente nel 1300, anno giubilare, ma soprattutto anno carico nei simbolismi numerici del suo totale riferimento a Dio, la vita sua si sarebbe dovuta compiere a 70 anni. Ed invece Dante sparisce a 56 anni con un tracollo che avviene in poco tempo, senza che ci siano avvisaglie. Ma questo suo inabissarsi nella morte, che tutto vorrebbe assorbire e sfiorire, diventa in realtà l’ingresso in un mondo che gli dà giustamente fama ed eternità. È quello che lui stesso avverte di meritare, pur in mezzo all’amarezza di un esilio che diventa di giorno in giorno sempre più duro e senza sbocchi. Mentre la sua situazione di esiliato si incancrenisce e addirittura si fa senza speranza con la condanna a morte, non solo sua, ma anche dei figli, dopo la battaglia di Montecatini (1315), oltre a cercare la sua pace fra chi lo ammira e lo desidera, si dedica con tutte le sue forze ad ultimare la grande opera, ormai salendo sempre più fino all’ultimo cielo. C’è dunque anche in questo suo cammino come un’aspirazione alla pace eterna, senza per questo che egli si possa augurare la morte o possa cercarla. Semmai è a Firenze che si insiste nel volere la condanna alla pena capitale. Egli piuttosto aspira al riconoscimento pubblico della sua grandezza di poeta e forse anche per questo cerca chi lo possa comprendere e sostenere in questa sua aspirazione, accogliendo l’invito del Signore di Ravenna, che ha pure interessi e sensibilità per la poesia.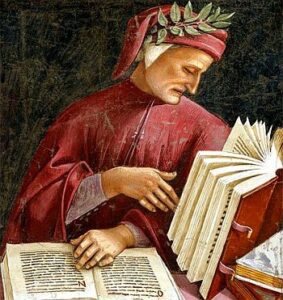 L’ammirazione che Dante nutre per l’Impero non è certo riposta in una forma istituzionale, come di fatto si presentava in quegli anni: essa appariva indubbiamente già superata; e si presentava come un ideale non più proponibile, anche perché l’ultimo erede,
L’ammirazione che Dante nutre per l’Impero non è certo riposta in una forma istituzionale, come di fatto si presentava in quegli anni: essa appariva indubbiamente già superata; e si presentava come un ideale non più proponibile, anche perché l’ultimo erede, 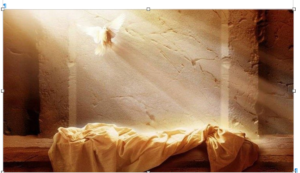
 Il 25 marzo, festa dell’Incarnazione, perché siamo esattamente a 9 mesi di distanza dal Natale, è sempre stato nel calendario cristiano un giorno molto significativo, assommando in sé i grandi misteri della fede cristiana: soprattutto nel Medioevo qui si collocava la data dell’inizio del mondo, della Creazione, in quanto il rinnova-mento primaverile, legato all’equinozio e nello stesso tempo al plenilunio in corso, fa pensare che qui sia iniziato il ciclo naturale e qui venga continuamente ripreso ogni anno. Proprio nella medesima circostanza viene collocato l’inizio della vita umana del Redentore, che viene concepito all’annuncio dell’angelo nell’utero di Maria. Lo stesso ciclo vitale viene ripreso con la Redenzione, collocata nella medesima data, perché la Pasqua ebraica, che ricorda l’uscita dall’Egitto e il passaggio del Mar Rosso viene collocata in occasione del plenilunio di primavera, così come è rimasta legata ad esso anche nell’ambito cristiano.
Il 25 marzo, festa dell’Incarnazione, perché siamo esattamente a 9 mesi di distanza dal Natale, è sempre stato nel calendario cristiano un giorno molto significativo, assommando in sé i grandi misteri della fede cristiana: soprattutto nel Medioevo qui si collocava la data dell’inizio del mondo, della Creazione, in quanto il rinnova-mento primaverile, legato all’equinozio e nello stesso tempo al plenilunio in corso, fa pensare che qui sia iniziato il ciclo naturale e qui venga continuamente ripreso ogni anno. Proprio nella medesima circostanza viene collocato l’inizio della vita umana del Redentore, che viene concepito all’annuncio dell’angelo nell’utero di Maria. Lo stesso ciclo vitale viene ripreso con la Redenzione, collocata nella medesima data, perché la Pasqua ebraica, che ricorda l’uscita dall’Egitto e il passaggio del Mar Rosso viene collocata in occasione del plenilunio di primavera, così come è rimasta legata ad esso anche nell’ambito cristiano. All’apertura dell’ultimo canto del Paradiso si eleva una magnifica preghiera alla Vergine, messa in bocca a S. Bernardo da Dante. Il santo è conosciuto come il cantore di Maria per le stupende omelie e preghiere che ha disseminato nelle sue opere. È una preghiera che il mistico abate medievale innalza a Maria perché Dante, rappresentante di ogni uomo, possa elevarsi a Dio, non senza la grazia che giunge all’uomo per l’intercessione di Maria. C’è tutta l’ammirazione e, insieme, si esprime la devozione con la quale l’animo si eleva a colei che è qui descritta nelle diverse “antinomie” come una creatura impareggiabile, come il prodigio scaturito dalla mente e dal cuore di Dio, vertice vertiginoso di ciò che il Creatore ha fatto, compia-cendosi poi di essere “fatto” lui stesso in lei. La preghiera si snoda in sette terzine (anche se poi continua con la parte dedicata alla supplica particolare per Dante che deve entrare al sommo del Paradiso). Queste distribuiscono l’orazione in tre momenti: le prime tre terzine sono una esaltazione di Maria, la più bella fra le creature di Dio e nel contempo la creatura umana che diventa la terra accogliente perché possa spuntare il fiore di Dio nella valle desolata. La terzina successiva, il cuore della preghiera, dice che lei è pure il punto di incontro fra i beati e quanti sono ancora nell’esilio terreno, come fiaccola di carità per i primi e fontana di speranza per i secondi. La supplica si esprime poi nelle ultime terzine con il riconoscimento che solo da lei ci può essere la garanzia perché la preghiera arrivi a Dio e la grazia di Dio raggiunga la debolezza umana. E così la preghiera con lei può avere le ali per raggiungere Dio, come da lei possono passare all’uomo la misericordia, la pietà e la bontà stessa di Dio, di cui lei è ricolma e che da lei si riversa pienamente in ogni creatura. Questa “
All’apertura dell’ultimo canto del Paradiso si eleva una magnifica preghiera alla Vergine, messa in bocca a S. Bernardo da Dante. Il santo è conosciuto come il cantore di Maria per le stupende omelie e preghiere che ha disseminato nelle sue opere. È una preghiera che il mistico abate medievale innalza a Maria perché Dante, rappresentante di ogni uomo, possa elevarsi a Dio, non senza la grazia che giunge all’uomo per l’intercessione di Maria. C’è tutta l’ammirazione e, insieme, si esprime la devozione con la quale l’animo si eleva a colei che è qui descritta nelle diverse “antinomie” come una creatura impareggiabile, come il prodigio scaturito dalla mente e dal cuore di Dio, vertice vertiginoso di ciò che il Creatore ha fatto, compia-cendosi poi di essere “fatto” lui stesso in lei. La preghiera si snoda in sette terzine (anche se poi continua con la parte dedicata alla supplica particolare per Dante che deve entrare al sommo del Paradiso). Queste distribuiscono l’orazione in tre momenti: le prime tre terzine sono una esaltazione di Maria, la più bella fra le creature di Dio e nel contempo la creatura umana che diventa la terra accogliente perché possa spuntare il fiore di Dio nella valle desolata. La terzina successiva, il cuore della preghiera, dice che lei è pure il punto di incontro fra i beati e quanti sono ancora nell’esilio terreno, come fiaccola di carità per i primi e fontana di speranza per i secondi. La supplica si esprime poi nelle ultime terzine con il riconoscimento che solo da lei ci può essere la garanzia perché la preghiera arrivi a Dio e la grazia di Dio raggiunga la debolezza umana. E così la preghiera con lei può avere le ali per raggiungere Dio, come da lei possono passare all’uomo la misericordia, la pietà e la bontà stessa di Dio, di cui lei è ricolma e che da lei si riversa pienamente in ogni creatura. Questa “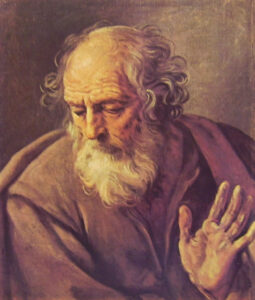 N.B. Non è stato possibile inserire tutte le foto previste, nè inserire il link al file per i limiti imposti dalla piattaforma.
N.B. Non è stato possibile inserire tutte le foto previste, nè inserire il link al file per i limiti imposti dalla piattaforma.