PREMESSA:
IL CRISTIANESIMO E IL PREGIUDIZIO
La religione cristiana si è presentata come una derivazione dal mondo ebraico: fin dalle sue origini, i promotori della sua diffusione, i discepoli mandati “fino agli estremi confini della terra” da Cristo dipendono strettamente dalla sinagoga, che frequentano tutti i sabati per le letture, mentre, passato il sabato, la sera stessa di quel giorno, si trovano nelle case per “la cena”, che diventerà progressivamente la loro riunione caratteristica. Fino al 70, anno della distruzione di Gerusalemme, i cristiani, pur nella diffidenza e nell’ostilità dei farisei e dei sacerdoti del tempio, cercano sempre il contatto con la sinagoga, come vediamo fare da Paolo nei suoi viaggi. E nei primi discorsi che troviamo riassunti da Luca negli Atti degli Apostoli, appare con chiarezza che il Dio di Cristo è sempre quello dei Padri d’Israele, e che dunque deve essere rivendicato questo legame con la storia ebraica. Anche tra la gente comune si riflette questa impostazione: quando a Roma, nel 49, avvengono tumulti a causa delle contestazioni ebraiche nei confronti dei cristiani, dovute a motivo di un certo Cristo, che, per quanto scrive Svetonio (“impulsore Chresto”), sembrava essere il fomentatore delle risse, Claudio volendo la pace e la tranquillità, decide di mandar via tutti, Ebrei e Cristiani. E così accontenta la popolazione che voleva la quiete pubblica. Ma di fatto il decreto di espulsione non va a buon fine, se molti rimangono ed altri confluiscono a Roma, dove, secondo Tacito, arriva di tutto, comprese le superstizioni più vergognose. Lo storico dice questo, mentre sta raccontando che Nerone si defila dalla responsabilità dell’incendio, che lui ha appiccato ad alcuni quartieri della città, accusando i cristiani di questo. Nell’esposizione si deve notare che lo storico ha raccolto alcune informazioni sul Cristo, pur riconoscendo questa fede come una pericolosa superstizione.
Nerone si inventò dei colpevoli e colpì con pene di estrema crudeltà coloro che, odiati per il loro comportamento contro la morale, il popolo chiamava Cristiani. Colui al quale si doveva questo nome, Cristo, nato sotto l’impero di Tiberio, attraverso il procuratore Ponzio Pilato era stato messo a morte; e quella pericolosa superstizione, repressa sul momento, tornava di nuovo a manifestarsi, non solo in Giudea, luogo d’origine di quella sciagura, ma anche a Roma, dove confluisce e si celebra tutto ciò che d’atroce e vergognoso giunge da ogni parte del mondo.
2
Perciò si può ben comprendere che, se pochi anni dopo si scatena la repressione degli Ebrei e la distruzione di Gerusalemme, per la loro opposizione in armi al dominio romano, i cristiani devono far di tutto per tenersi alla larga da quel mondo e per creare una immagine di sé che non li associ al mondo ebraico, per quanto esso non possa essere del tutto cancellato. Di fatto i cristiani si trovano a vivere in un mondo che non sembra dimostrare accoglienza, rispetto, considerazione, approvazione. Eppure gli adepti aumentano, anche se dalle fonti sembra che si tratti di gente che sta ai margini della società e che confluisce nel Cristianesimo, sentendo parlare di liberazione dalla schiavitù e di un Regno futuro da vivere nella giustizia e nella fraternità. Così la diffidenza aumenta, come se si avvertisse proveniente da lì una sorta di rivoluzione sociale la quale potrebbe sovvertire il sistema e quindi anche l’equilibrio di potere. Fa specie che anche gli imperatori, definiti “adottivi”, quelli che si succedono dopo Cocceio Nerva (96-98), risultano ostili al mondo cristiano e favoriscano interventi vessatori nei loro confronti. Eppure questi imperatori appaiono capaci di un buon governo, guidati da buoni principi, dediti al-la cultura, ammirati un po’ dovunque. Se le persecuzioni scatenate da Nerone (54-68), prima, e da Domiziano (81-96), poi, apparivano come follie vessatorie di un potere costruito sulla violenza, non altrettanto si deve dire a proposito di ciò che succede con Traiano, il quale risulta uno dei migliori imperatori di questo periodo. Eppure possediamo di lui la risposta data al suo collaboratore nel Ponto, Plinio il Giovane, il quale chiedeva istruzioni sulla questione che comunque il governatore di origini comasche già affrontava con interrogatori e con punizioni esemplari, per quanto non ci fossero giustificazioni di sorta a partire dall’ammissione di colpe e di reati. La sola motivazione per questo accanimento era la pertinacia dei soggetti nel voler perseguire la propria religione, aborrendo quella tradizionale. Così Plinio scrive e chiede delucidazioni a cui Traiano risponde.
È per me un dovere, o signore, deferire a te tutte le questioni in merito alle quali sono incerto. Chi infatti può meglio dirigere la mia titubanza o istruire la mia incompetenza? Non ho mai preso parte ad istruttorie a carico dei Cristiani (…) Nel frattempo, con coloro che mi venivano deferiti quali Cristiani, ho seguito questa procedura: chiedevo loro se fossero Cristiani. Se confessavano, li interrogavo una seconda e una terza volta, minacciandoli di pena capitale; quelli che perseveravano, li ho mandati a morte.
3
Infatti non dubitavo che, qualunque cosa confessassero, dovesse essere punita la loro pertinacia e la loro cocciuta ostinazione. Ve ne furo-no altri affetti dalla medesima follia, i quali, poiché erano cittadini romani, ordinai che fossero rimandati a Roma. (…) Affermavano inoltre che tutta la loro colpa o errore consisteva nell’esser soliti riunirsi prima dell’alba e intonare a cori alterni un inno a Cristo come se fosse un dio, e obbligarsi con giuramento non a perpetrare qualche delitto, ma a non commettere né furti, né frodi, né adulteri, a non mancare alla parola data e a non rifiutare la restituzione di un deposito, qualora ne fossero richiesti. Fatto ciò, avevano la consuetudine di ritirarsi e riunirsi poi nuovamente per prendere un cibo, ad ogni modo comune e innocente, cosa che cessarono di fare dopo il mio editto nel quale, secondo le tue disposizioni, avevo proibito l’esistenza di sodalizi. (…) Non ho trovato null’altro al di fuori di una superstizione balorda e smodata. Perciò, differita l’istruttoria, mi sono affrettato a richiedere il tuo parere. Mi parve infatti cosa degna di consultazione, soprattutto per il numero di coloro che sono coinvolti in questo peri-colo; molte persone di ogni età, ceto sociale e di entrambi i sessi, vengono trascinati, e ancora lo saranno, in questo pericolo. Né soltanto la città, ma anche i borghi e le campagne sono pervase dal contagio di questa superstizione; credo però che possa esser ancora fermata e riportata nella norma.
La risposta lascia perplessi circa il senso di giustizia, perché la colpevolezza riconosciuta dovrebbe essere solo quella di non adeguarsi alle tradizioni religiose, quando si sapeva già che a Roma tutto era di fatto tollerabile, purché non in conflitto con le leggi fondamentali …
Non li si deve ricercare; qualora vengano denunciati e riconosciuti colpevoli, li si deve punire …
In presenza di interventi del genere era necessario cercare una risposta adeguata da parte dei cristiani, che spesso subivano il martirio sempre con eroismo, anche a sapere che la loro condanna risultava ingiusta e ingiustificata sulla base della legge comune. Essa era sempre più determinata da una sorta di capriccio dell’autorità locale e per prevenire forme di intolleranza nell’opinione pubblica. Le riunioni dei cristiani nelle case prestavano il fianco a pregiudizi e creavano il sospetto che simili riunioni fossero come delle congiure o covassero trame oscure. Del resto i Cristiani in questo periodo erano occupati a consolidare le comunità dove spesso serpeggiava la disunione a causa dei personalismi, e la questione richiedeva la preparazione adeguata di quanti dovevano sostenere la responsabilità di governo delle comunità stesse.
4
Ma non manca la necessità di opporre alle obiezioni formulate da Plinio una risposta che favorisse una conoscenza migliore dei cristiani e di ciò che essi facevano, scongiurando in tal modo il pregiudizio, sulla base del quale non solo si assisteva alle violenze private locali, ma anche alla formulazione di ordini disciplinari da estendere un po’ ovunque nell’impero. Quanto si trova scritto nella corrispondenza fra Traiano e Plinio diventa di fatto una norma da seguire e a cui ci si rifà anche nei secoli successivi per giustificare interventi punitivi. Non abbiamo una specie di incarico affidato per redigere un documento in difesa dei cristiani in simili circostanze; e però c’è chi si assume l’onere con un testo, che sembra rispondere alle obiezioni formulate al tempo di Traiano. Nel II secolo emerge la figura di Giustino, il primo filosofo cristiano …
S. GIUSTINO (100-163/7)
Ciò che sappiamo di lui lo deriviamo dai suoi testi.
Io, Giustino, di Prisco, figlio di Baccheio, nativi di Flavia Neapoli, città della Siria di Palestina, … (I apologia I)
Il nome è di chiara derivazione latina; per quanto lui si ritenga samaritano, perché nato nella località che oggi è chiamata Nablus. Dobbiamo ritenere che i suoi vengano da Roma, o comunque dal mondo latino, forse collocati in questo angolo di mondo che doveva essere controllato dopo la distruzione di Gerusalemme e nell’imminenza di un ennesimo scontro che avvenne nel 135, quando l’editto di Adriano stabiliva che gli Ebrei non potessero più stare in Palestina. Sulla base di ciò che troviamo nel suo libro filosofico, Giustino ebbe la possibilità di una buona educazione, se poi la sua giovinezza viene vissuta nella ricerca di natura filosofica, passando da diverse dottrine, sempre appassionato per la verità. Lui stesso si considera filosofo …
Ti dirò come vedo io le cose, dissi. La filosofia in effetti è il pi grande dei beni e il più prezioso agli occhi di Dio, l’unico che a lui ci conduce e a lui ci unisce, e sono davvero uomini di Dio coloro che han volto l’animo alla filosofia. Ciò nondimeno ai più è sfuggito che cos’è la filosofia perché mai è stata inviata agli uomini: diversamente non ci sarebbero stati né platonici né stoici né teoretici né pitagorici, perché unico è il sapere filosofico. (Dialogo 2,1)
5
Ma la sete di verità, inappagata in tutte le scuole filosofiche percorse, lo fa approdare alla “vera filosofia”, che per lui è il Cristianesimo.
E chi mai si potrà prendere come maestro, feci io, e di dove si potrà trarre giovamento se neppure in uomini come Platone e Pitagora si trova la verità?
Molto tempo fa, prima di tutti costoro che son tenuti per filosofi, vissero uomini beati, giusti e graditi a Dio, che parlavano mossi dallo spirito divino e predicevano le cose future che si sono ora avverate. Li chiamano profeti e sono i soli che hanno visto la verità e l’hanno annunciata agli uomini senza remore o riguardo per nessuno e senza farsi dominare dall’ambizione, ma proclamando solo ciò che, ripieni di Spirito santo, avevano visto e udito …
(Dialogo 7,1)
… Quanto a me, un fuoco divampò all’istante nel mio animo e mi pervase l’amore per i profeti e per quegli uomini che sono amici di Cristo. Ponderando tra me e me le sue parole trovai che questa era l’unica filosofia certa e proficua.
(Dialogo 8,1)
Questa sua immagine di filosofo e il lavoro introdotto per cercare di offrire basi razionali alla fede cristiana gli crearono non pochi problemi: nel mondo filosofico ebbe detrattori che lo accusavano di essere uscito dagli schemi comunemente accettati perché un discorso fosse considerato di natura filosofica, e nel contempo anche nel mondo cristiano il suo lavoro di razionalizzazione gli procurava qualche contrasto. Per lui, dunque, profeti dell’Antico Testamento e filosofi greci potevano essere buoni compagni di viaggio per condurre a Cristo, il solo obiettivo da raggiungere nella ricerca; e questo sta alla base del suo lavoro di ricercatore. Anche per le opere che ci sono giunte dobbiamo riconoscere che egli è debitore agli Ebrei e i pagani di quei testi che comunque non possono costituire da soli la base della verità, ma sono semplicemente come pedagoghi che conducono a Cristo, e a lui si deve approdare. Lo dice con estrema chiarezza Benedetto XVI nella sua catechesi, tenuta il 21 marzo 2007.
Se l’Antico Testamento tende a Cristo come la figura orienta verso la realtà significata, la filosofia greca mira anch’essa a Cristo e al Vangelo, come la parte tende a unirsi al tutto. E dice che queste due realtà, l’Antico Testamento e la filosofia greca, sono come le due strade che guidano a Cristo, al Logos. Ecco perché la filosofia greca non può opporsi alla verità evangelica, e i cristiani possono attingervi con fiducia, come a un bene proprio.
6
LE APOLOGIE
Gli scritti apologetici, ancora oggi, sono formulati in difesa della fede e servono a trovare argomenti da opporre a chi mette in dubbio tutto ciò che attiene alla religione o vuol contestare chi crede. In presenza di un diffuso pregiudizio è quanto mai opportuno opporre chiarimenti, anche senza far ricorso a polemiche dominate dall’astio, spesso accompagnato dal sarcasmo. Giustino cerca sempre di ricorrere a buone argomentazioni sulla base del suo armamentario filosofico razionale e, dovendo difendersi utilizza termini e discorsi che possano servire allo scopo, sapendo che il suo documento scritto è rivolto all’autorità suprema dello Stato e ai suoi collaboratori. Non scrive per la gente comune, ma si riferisce a quanti nella loro responsabilità di governo devono considerare i cristiani come sudditi dello Stato e proprio per questo necessitano di un trattamento giusto nella misura in cui anch’essi sono leali verso lo Stato. Esistono due apologie scritte da Giustino: la prima è indirizzata all’imperatore di quel tempo, Antonino detto il Pio (138-161), ma anche “al senato e al popolo romano”, sulla base delle formule in uso; la seconda è inviata al solo senato. Entrambe comunque sono redatte come un appello alle autorità perché prendano in considerazione quanti aderiscono alla religione cristiana per non essere oggetto di vessazioni e di ingiuste persecuzioni.
LA PRIMA APOLOGIA
Appare in maniera evidente da parte dell’autore che la persecuzione in atto nei confronti dei cristiani, anche a non essere dichiarata, come avverrà successivamente, non ha ragion d’essere, per il fatto che mancano reati punibili e tutto si compie sulla base del pregiudizio. Tenendo conto che il primo referente dello scritto è l’imperatore che viene definito “Pio” e che appartiene alla categoria dei filosofi, come è pure il suo successore designato, Marco Aurelio (161-180), lo scrivente, appellandosi alla razionalità, chiede loro di esprimere un giudizio sulla base di un attento esame della questione. Egli non vuole accattivarsi la simpatia e neppure chiedere pietà, ma che si giudichi sulla base di un criterio razionale. Rimane comunque alle autorità la decisione di giungere ad una pena inappellabile, segno che l’autorità può tutto; ma, se essa si fonda dul raziocinio, come è per imperatori filosofi, allora è necessario che il loro intervento censorio abbia un suo senso.
7
All’imperatore Tito Elio Adriano Antonino Pio Cesare Augusto e al figlio Verissimo filosofo, ed a Lucio, figlio del Cesare filosofo e, per adozione, del Pio, amante del sapere, al Sacro Senato ed a tutto il popolo romano. Io, Giustino, di Prisco, figlio di Baccheio, nativi di Flavia Neapoli, città della Siria di Palestina, ho composto questo discorso e questa supplica, in difesa degli uomini di ogni stirpe ingiustamente odiati e perseguitati, io che sono uno di loro. La ragione suggerisce che quelli che sono davvero pii e filosofi onorino e amino solo il vero, evitando di seguire le opinioni degli antichi qualora siano false. Infatti la retta ragione suggerisce non solo di non seguire chi agisce o pensa in modo ingiusto, ma bisogna che in ogni modo e al di sopra della propria vita, colui che ama la verità, anche se è minacciato di morte, scelga sia di dire sia di fare il giusto. Voi dunque godete in ogni luogo la fama di essere pii e filosofi e custodi della giustizia e amanti della sapienza: se poi davvero anche lo siete, sarà dimostrato. Eccoci infatti dinanzi a voi non per adularvi attraverso questi scritti né per parlarvi in modo accattivante, ma per chiedervi di pronunciare il giudizio secondo il criterio di un attento e preciso esame, senza attenervi a pregiudizi né al desiderio di piacere a gente superstiziosa: ritorcereste la condanna contro di voi stessi, con un comportamento irragionevole e seguendo una cattiva fama ormai inveterata. Noi infatti siamo persuasi che non possiamo subire alcun male da alcuno, a meno che si provi che siamo operatori di malvagità o che si riconosca che siamo malvagi: voi potete sì ucciderci, ma non nuocerci. (I Apologia I-II)
Una delle accuse ricorrenti, mosse ai cristiani, è quella di essere atei, mancando ad essi quella forma di “pietas”, che piegandoli al volere di Dio, li fa elevare a Dio stesso. Il fatto che essi invece abbiano elevato un uomo al rango di Dio, tenuto conto poi che è stato condannato a morte in maniera infamante, fa pensare che essi non ricorrano affatto a chi “abita in alto”.
Di qui ci è anche derivata l’accusa di atei. Certo ammettiamo di essere tali ri-spetto a questi supposti dèi, ma non certo rispetto a Dio verissimo, padre di giustizia e di sapienza e di ogni virtù, e immune da malvagità. Lui veneriamo e adoriamo, e il Figlio che da Lui è venuto e che ci ha insegnato queste dottrine, con l’esercito degli altri angeli buoni che Lo seguono e Lo imitano e lo Spirito Profetico: li onoriamo con ragione e verità trasmettendo con generosità quanto abbiamo imparato a chiunque voglia apprenderlo.
(I Apologia VI)
8
Dunque, quale persona ragionevole non ammetterà che noi non siamo atei, dal momento che veneriamo il creatore di questo universo e diciamo che Egli non ha bisogno di sangue e di libagioni e di profumi, come ci è stato insegnato, e lo lodiamo, per quanto possono le nostre forze, con espressioni di preghiera e rendimento di grazie per tutto ciò che ne riceviamo, poiché sappiamo che il solo onore degno di lui è non consumare nel fuoco ciò che da lui ci viene per il nostro sostentamento, ma distribuirlo fra noi stessi e a quanti ne hanno bisogno? Sappiamo essergli grati, innalzandogli lodi e inni per essere stati creati e per tutti i mezzi atti a procurarci benessere per tutte le qualità dei prodotti e la varietà delle stagioni, ed elevandogli preghiere per vivere poi nell’incorruttibilità, a nostra volta, attraverso la fede in Lui. Dimostreremo poi che a ragione noi veneriamo Colui che ci è stato maestro di queste dottrine, e per questo è stato generato, Gesù Cristo, crocifisso sotto Ponzio Pilato, governatore della Giudea al tempo di Tiberio Cesare; abbiamo appreso che Egli è il figlio del vero Dio, e Lo onoriamo al secondo posto, ed in terzo luogo lo Spirito Profetico. In questo credono di dimostrare la nostra follia, dicendo che noi diamo il secondo posto, dopo l’immutabile ed eterno Dio, creatore di tutte le cose, ad un uomo posto in croce, poiché non conoscono il mistero che vi è dentro: questo vi esortiamo a considerare attentamente, poiché ci apprestiamo a spiegarvelo. (I Apologia XIII)
Giustino aggiunge di essere un suddito fedele dell’Impero, e i cristiani, come del resto nel vangelo è suggerito di dare a Cesare quello che è di Cesare, sono disposti a pagare i tributi, e quindi a servire lealmente lo Stato e addirittura a pregare per le legittime autorità. Seguono puntualizzate le accuse mosse ai cristiani, fra le quali quella di infanticidio, e Giustino risponde che i cristiani non sono affatto come fanno credere tanti pregiudizi accumulati su di loro, disseminando il mondo di falsità e odiosità nei loro confronti. Espone in maniera sintetica ciò che è scritto nei Vangeli per far conoscere la figura di Cristo, sia in riferimento alla sua nascita verginale, sia in riferimento alla sua morte di croce. Non manca neppure il riferimento alla devastazione di Gerusalemme, di cui si trova, come previsione, la traccia anche nel vangelo, scritto in realtà “post factum”: si avverte in Giustino la ricerca di una sorta di “captatio benevolentiae”, perché i suoi interlocutori erano intenti in quegli anni a fare una sorta di bonifica della Palestina dalla presenza degli Ebrei, con l’intento di cacciarli definitivamente da quel territorio, che appariva a loro non sufficientemente sottomesso all’autorità romana. È un incalzare di buone argomentazioni nell’intento di far desistere le autorità dal ricorso alla violenza per avere la meglio dei cristiani, analogamente a quanto veniva fatto in quei tempi agli Ebrei, soprattutto residenti in Palestina.
9
E si aggiunge anche l’argomentazione che la violenza non fa desistere i cristiani dal conservarsi tali, anche se non mancano gli apostati.
I cattivi demoni non riescono a persuadere che non esiste il fuoco come punizione per gli empi, così come non poterono tenere nascosta la venuta di Cristo. Solo questo possono fare: che chi vive contro ragione, è cresciuto perversamente nei cattivi costumi ed è schiavo delle false opinioni, ci uccida e ci odi. Noi comunque non solo non li odiamo, ma – come è dimostrato – ne abbiamo pietà e desideriamo persuaderli a cambiare. Infatti non temiamo la morte, poiché sappiamo che, comunque, si muore e che non c’è niente di nuovo, ma in questo ordine di cose ritornano sempre le medesime realtà. Se di esse sente nausea chi ne fruisce anche solo per un anno, per essere per sempre liberi da passioni e da bisogni, occorre approdare alle nostre dottrine. Se poi si mostrano increduli asserendo che non c’è nulla dopo la morte e dichiarano che i morti raggiungono l’insensibilità, a noi fanno del bene, sottraendoci ai patimenti ed alle necessità di quaggiù; mentre, invece, mostrano se stessi malvagi, non umani e schiavi delle opinioni: infatti ci uccidono non per liberarci, ma per i privarci della vita e del piacere.
(I Apologia LVII)
La parte più interessante per noi di questo lungo scritto è quella conclusiva, dove abbiamo la descrizione di ciò che si fa nelle riunioni dei cristiani, tenuto conto delle tante accuse che vengono fatte per quelle assemblee, dove si immaginano nefandezze. Ed invece Giustino presenta con estrema chiarezza la celebrazione del sacramento che introduce alla fede cristiana e quindi il battesimo e poi la celebrazione dell’assemblea domenicale dell’Eucaristia, nella quale troviamo gli elementi essenziali ancora oggi praticati e in alcuni elementi ripristinati dalla riforma conciliare recente.
IL BATTESIMO
Esporremo in quale modo ci siamo consacrati a Dio, rinnovati da Cristo, affinché non sembri che, tralasciando questa parte, viziamo in qualche modo la nostra esposizione. A quanti siano persuasi e credano che sono veri gli insegnamenti da noi esposti, e promettano di saper vivere coerentemente con questi, si insegna a pregare ed a chiedere a Dio, digiunando, la remissione dei peccati, mentre noi preghiamo e digiuniamo insieme con loro. Poi vengono condotti da noi dove c’è l’acqua, e vengono rigenerati nello stesso modo in cui fummo rigenerati anche noi: allora infatti fanno il lavacro nell’acqua, nel nome di Dio, Padre e Signore dell’universo, di Gesù Cristo nostro salvatore e dello Spirito Santo.
10
Poiché Cristo disse: “Se non sarete rigenerati, mai entrerete nel regno dei cieli”: è chiaro a tutti che è impossibile, una volta che si sia nati, rientrare nel ventre della madre. E dal profeta Isaia – come prima scrivemmo – è stato detto in che modo sfuggiranno ai peccati coloro che hanno peccato e si pentono. Ecco le sue parole: “Lavatevi, divenite puri, allontanate il male dalle vostre anime, imparate a fare il bene, difendete l’orfano, rendete giustizia alla vedova; allora venite e ragioniamo – dice il Signore. – E se anche i vostri peccati sono come porpora, li renderò bianchi come lana; e se anche sono come cremisi, li renderò bianchi come neve; ma se non mi ascolterete, una spada vi divorerà. Così infatti parlò la bocca del Signore”. E in proposito ecco la ragione che apprendemmo dagli apostoli. Poiché, nulla sapendo della nostra prima generazione, secondo necessità siamo stati generati da umido seme per l’unione dei genitori, e per natura abbiamo cattivi costumi e malvagie inclinazioni, per non rimanere figli di necessità e di ignoranza, bensì di libera scelta e di sapienza, e per ottenere la remissione dei peccati commessi prima, su colui che ha deciso di rigenerarsi e si è penti-to dei peccati si invoca, nell’acqua, il nome di Dio, Padre e Signore dell’uni-verso: e questo solo nome pronuncia chi conduce al lavacro colui che deve sottoporvisi. Nessuno infatti può dare un nome al Dio ineffabile; e se qualcuno osasse dire che ne esiste uno, sarebbe inguaribilmente pazzo. Questo lavacro si chiama “illuminazione”, poiché coloro che comprendono queste cose sono illuminati nella mente. E chi deve essere illuminato viene lavato nel nome di Gesù Cristo, crocifisso sotto Ponzio Pilato; e nel nome dello Spirito Santo, che ha preannunziato per mezzo dei Profeti tutti gli eventi riguardanti Gesù. (I Apologia LXI)
Non si rileva un intento polemico nella descrizione del Battesimo, dove, rispetto al rito, si dice poco, mentre molto si vuol chiarire circa il senso dell’immersione nell’acqua, non solo volendo spiegare che si tratta di una purificazione, ma anche e soprattutto di una illuminazione. Chi legge, probabilmente non avrà da queste parole una spiegazione esauriente, perché il Battesimo comporta la presa di coscienza dell’appartenenza a Dio, che fa agire diversamente da chi, non illuminando la coscienza, si lascia andare alle forme istintive. Una simile presentazione del gesto purificatore induce a pensare che Giustino non sia preoccupato solo di difendersi da visioni negative che erano diffuse fra la gente ostile al mondo cristiano; qui si parla di “libera scelta e di sapienza”, per cui il rito non ha niente di “misterioso” e di esoterico; esso assume i contorni di una adesione personale, libera e soprattutto ben ponderata. Avvenendo nel nome delle persone divine essa non è adesione ad una dottrina, ma a persone.
11
L’EUCARISTIA
Noi allora, dopo aver così lavato chi è divenuto credente e ha aderito, lo conduciamo presso quelli che chiamiamo fratelli, dove essi si trovano radunati, per pregare insieme fervidamente, sia per noi stessi, sia per l’illuminato, sia per tutti gli altri, dovunque si trovino, affinché, appresa la verità, meritiamo di essere nei fatti buoni cittadini e fedeli custodi dei precetti, e di conseguire la salvezza eterna. Finite le preghiere, ci salutiamo l’un l’altro con un bacio. Poi al preposto dei fratelli vengono portati un pane e una coppa d’acqua e di vino temperato; egli li prende ed innalza lode e gloria al Padre dell’universo nel nome del Figlio e dello Spirito Santo, e fa un rendimento di grazie per essere stati fatti degni da Lui di questi doni. Quando egli ha terminato le preghiere ed il rendimento di grazie, tutto il popolo presente acclama: “Amen”. La parola “Amen” in lingua ebraica significa “sia”. Dopo che il preposto ha fatto il rendimento di grazie e tutto il popolo ha acclamato, quelli che noi chiamiamo diaconi distribuiscono a ciascuno dei presenti il pane, il vino e l’acqua consacrati e ne portano agli assenti. Questo cibo è chiamato da noi Eucaristia, e a nessuno è lecito parteciparne, se non a chi crede che i nostri insegnamenti sono veri, si è purificato con il lavacro per la remissione dei peccati e la rigenerazione, e vive così come Cristo ha insegnato. Infatti noi li prendiamo non come pane comune e bevanda comune; ma come Gesù Cristo, il nostro Salvatore incarnatosi, per la parola di Dio, prese carne e sangue per la nostra salvezza, così abbiamo appreso che anche quel nutrimento, consacrato con la preghiera che contiene la parola di Lui stesso e di cui si nutrono il nostro sangue e la nostra carne per trasformazione, è carne e sangue di quel Gesù incarnato. Infatti gli Apostoli, nelle loro memorie chiamate vangeli, tramandarono che fu loro lasciato questo comando da Gesù, il quale prese il pane e rese grazie dicendo: “Fate questo in memoria di me, questo è il mio corpo”. E parimenti, preso il calice e rese grazie disse: “Questo è il mio sangue”; e ne distribuì soltanto a loro. I malvagi demoni per imitazione, dissero che tutto ciò avveniva anche nei misteri di Mitra. Infatti voi già sapete, o potete apprendere, come nei riti di iniziazione si introducano un pane ed una coppa d’acqua, mentre si pronunciano alcune formule. Da allora noi ci ricordiamo a vicenda questo fatto. E quelli che possiedono, aiutano tutti i bisognosi e siamo sempre uniti gli uni con gli altri. Per tutti i beni che riceviamo ringraziamo il creatore dell’universo per il Suo Figlio e lo Spirito Santo. E nel giorno chiamato “del Sole” ci si raduna tutti insieme, abitanti delle città o delle campagne, e si leggono le memorie degli Apostoli o gli scritti dei Pro-feti, finché il tempo consente. Poi, quando il lettore ha terminato, il preposto con un discorso ci ammonisce ed esorta ad imitare questi buoni esempi.
12
Poi tutti insieme ci alziamo in piedi ed innalziamo preghiere; e, come abbiamo detto, terminata la preghiera, vengono portati pane, vino ed acqua, ed il preposto, nello stesso modo, secondo le sue capacità, innalza preghiere e rendimenti di grazie, ed il popolo acclama dicendo: “Amen”. Si fa quindi la spartizione e la distribuzione a ciascuno degli alimenti consacrati, ed attraverso i diaconi se ne manda agli assenti. I facoltosi, e quelli che lo desiderano, danno liberamente ciascuno quello che vuole, e ciò che si raccoglie viene depositato presso il preposto. Questi soccorre gli orfani, le vedove, e chi è indigente per malattia o per qualche altra causa, e i carcerati e gli stranieri che si trovano presso di noi: insomma, si prende cura di chiunque sia nel bisogno. Ci raccogliamo tutti insieme nel giorno del Sole, poiché questo è il primo giorno nel quale Dio, trasformate le tenebre e la materia, creò il mondo; sempre in questo giorno Gesù Cristo, il nostro Salvatore, risuscitò dai morti. Infatti Lo crocifissero la vigilia del giorno di Saturno, ed il giorno dopo quello di Saturno, che è il giorno del Sole, apparve ai suoi Apostoli e discepoli, ed insegna proprio queste dottrine che abbiamo presentato anche a voi perché le esaminiate.
(I Apologia LXV-LXVII)
Anche per questa pagina si deve riconoscere che l’autore non è preoccupato di contestare le voci di popolo circa i contenuti dell’incontro domenicale, dove ci si immagina che avvengano infamità e turpitudini. Qui invece si descrivono esattamente le parti della Messa, comprese quelle che, nelle revisioni successive, sono scomparse e che recentemente sono state ripristinate, quasi derivandole dal testo di Giustino. Va rilevato che la spiegazione della Parola, fatta dal “preposto”, termine da cui poi deriverà quello del “prevosto”, anche se qui designa il presidente dell’assemblea, è parte integrante ed essenziale della liturgia eucaristica, così come la raccolta delle offerte devono servire alla carità e quindi al sostegno dei poveri. È pure da segnalare che la domenica viene qui designata come “il giorno del Sole” (il “Soledì” o Sunday).
LA SECONDA APOLOGIA
Il testo nasce da un episodio avvenuto negli anni di governo di Antonino Pio: la tensione tra un marito dissoluto e la moglie cristiana, che decide di divorziare dopo vani tentativi di portarlo a più miti consigli, arriva in tribunale dove il marito si presenta, accusando la moglie di essere plagiata da un cristiano. Costui viene citato in tribunale e si trova a finire come il vero imputato, a causa del riconoscimento da parte sua di essere cristiano. Egli viene alla fine condannato a morte, come pure coloro che cercano di intervenire in sua difesa.
13
Nel tribunale non viene affrontato il diverbio fra marito e moglie, ma solo la questione della confessione, fatta dal consulente della donna, di essere cristiano. Giustino aggiunge di trovarsi nella medesima condizione, a partire dal suo rivale in filosofia che lo accusa di essere ateo, solo perché egli non crede nella mitologia diffusa. Il suo accusatore non porta argomenti di natura filosofica, ma i soliti pregiudizi diffusi tra la gente comune. Nel suo ragionamento Giustino richiama il vero interlocutore della sua opera, che è il filosofo Crescenzio, a rivedere il suo giudizio malevolo sui cristiani, partendo dalla filosofia, analogamente a quello che ha fatto Socrate, sempre aperto alla ricerca. Giustino afferma che Socrate ha riconosciuto il Logos, cioè Cristo, non perché sia suo contemporaneo, ma perché la ricerca della verità mediante la ragione lo messo nella condizione di poter avere un’apertura mentale a quel Cristo che è già presente nel mondo, prima ancora che sia nato, come lo si può vedere nei profeti che ne preannunciano la venuta.
Quelli che vissero prima di Cristo e si sforzarono di investigare e di indagare le cose con la ragione, secondo le possibilità umane, furono trascinati dinanzi ai tribunali come empi e troppo curiosi. Colui che più di ogni altro tendeva a questo, Socrate, fu accusato delle stesse colpe che si imputano a noi: infatti dissero che egli introduceva nuove divinità, e che non credeva negli dèi che la città riteneva come tali. Invece egli insegnò agli uomini a rinnegare i demoni malvagi, autori delle empietà narrate dai poeti, facendo bandire dalla repubblica sia Omero sia gli altri poeti; cercava anche di spingerli alla conoscenza del Dio a loro ignoto, attraverso la ricerca razionale. Diceva: “Non è facile trovare il Padre e creatore dell’universo, né è sicuro che chi l’ha trovato lo riveli a tutti”. Questo è quanto fece il nostro Cristo con la Sua potenza. Infatti a Socrate nessuno credette fino al punto di morire per questa dottrina. A Cristo invece, conosciuto, almeno in parte, anche da Socrate (Egli infatti era ed è il Logos che è in ogni cosa, che ha predetto il futuro per mezzo dei Profeti e per mezzo di se stesso, che si è fatto come noi ed ha insegnato questa verità), credettero non solo i filosofi e dotti, ma anche operai e uomini assolutamente ignoranti, che sprezzarono i giudizi altrui, la paura, la morte. Poiché è potenza del Padre ineffabile e non costruzione di umana ragione. (II Apologia X)
Riconoscendo che la ricerca di Cristo come Logos è sempre presente nel cuore dell’uomo e che dunque Cristo è presente nel mondo prima ancora che compaia nella sua fisionomia umana, Giustino esalta la filosofia e nello stesso tempo, come filosofo, esalta pure la sua scelta di essere cristiano.
14
Su questo vuole essere valutato e riconosciuto come giusto, da rispettare e da onorare.
Io confesso di vantarmi e di combattere decisamente per essere trovato cri-stiano, non perché le dottrine di Platone siano diverse da quelle di Cristo, ma perché non sono del tutto simili, così come quelle degli altri, Stoici e poeti e scrittori. Ciascuno infatti, percependo in parte ciò che è congenito al Logos divino sparso nel tutto, formulò teorie corrette; essi però, contraddicendosi su argomenti di maggior importanza, dimostrano di aver posseduto una scienza non sicura ed una conoscenza non inconfutabile. Dunque ciò che di buono è stato espresso da chiunque, appartiene a noi cristiani. Infatti noi adoriamo ed amiamo, dopo Dio, il Logos che è da Dio non generato ed ineffabile, poiché Egli per noi si è fatto uomo affinché, divenuto partecipe delle nostre infermità, le potesse anche guarire. Tutti gli scrittori,
attraverso il seme innato del Logos, poterono oscuramente vedere la realtà. Ma una cosa è un seme ed un’imitazione concessa per quanto è possibile, un’altra è la cosa in sé, di cui, per sua grazia, si hanno la partecipazione e l’imitazione.
(II Apologia XIII)
Di fatto l’Apologia non divenne concretamente una difesa per la scelta di campo, operata da Giustino se lo stesso filosofo finisce negli ingranaggi di una spietata giustizia che lo conduce al patibolo. Abbiamo gli atti del suo martirio, una specie di resoconto notarile dell’interrogatorio a cui fu sottoposto con la conseguenza di finire condannato e giustiziato.
Dopo il loro arresto, i santi furono condotti dal prefetto di Roma di nome Rustico. Comparsi davanti al tribunale, il prefetto Rustico disse a Giustino: «Anzitutto credi agli dèi e presta ossequio agli imperatori». Giustino disse: «Di nulla si può biasimare o incolpare chi obbedisce ai comandamenti del Salvatore nostro Gesù Cristo». Il prefetto Rustico disse: «Quale dottrina professi?». Giustino rispose: «Ho tentato di imparare tutte le filosofie, poi ho aderito alla vera dottrina, a quella dei cristiani, sebbene questa non trovi simpatia presso coloro che sono irretiti dall’errore». Il prefetto Rustico disse: «E tu, miserabile, trovi gusto in quella dottrina?». Giustino rispose: «Sì, perché io la seguo con retta fede». Il prefetto Rustico disse: «E qual è questa dottrina?». Giustino rispose: «Quella di adorare il Dio dei cristiani, che riteniamo unico creatore e artefice, fin da principio, di tutto l’universo, delle cose visibili e invisibili; e inoltre il Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio, che fu preannunziato dai profeti come colui che doveva venire tra gli uomini araldo di salvezza e maestro di buone dottrine.
15
E io, da semplice uomo, riconosco di dire ben poco di fronte alla sua infinita Deità. Riconosco che questa capacità è propria dei profeti che preannunziarono costui che poco fa ho detto essere Figlio di Dio. So bene infatti che i profeti per divina ispirazione predissero la sua venuta tra gli uomini». Rustico disse: «Sei dunque cristiano?». Giustino rispose: «Sì, sono cristiano». Il prefetto disse a Giustino: «Ascolta, tu che sei ritenuto sapiente e credi di conoscere la vera dottrina; se dopo di essere stato flagellato sarai decapitato, ritieni di salire al cielo?». Giustino rispose: «Spero di entrare in quella dimora se soffrirò questo. Io so infatti che per tutti coloro che avranno vissuto santamente, è riservato il favore divino sino alla fine del mondo intero». Il prefetto Rustico disse: «Tu dunque ti immagini di salire al cielo, per ricevere una degna ricompensa?». Rispose Giustino: «Non me l’immagino, ma lo so esattamente e ne sono sicurissimo». Il prefetto Rustico disse: «Orsù torniamo al discorso che ci siamo proposti e che urge di più. Riunitevi insieme e sacrificate concordemente agli dèi». Giustino rispose: «Nessuno che sia sano di mente passerà dalla pietà all’empietà». Il prefetto Rustico disse: «Se non ubbidirete ai miei ordini, sarete torturati senza misericordia». Giustino rispose: «Abbiamo fiducia di salvarci per nostro Signore Gesù Cristo se saremo sottoposti alla pena, perché questo ci darà salvezza e fiducia davanti al tribunale più temibile e universale del nostro Signore e Salvatore». Altrettanto dissero anche tutti gli altri martiri: «Fa’ quello che vuoi; noi siamo cristiani e non sacrifichiamo agli idoli». Il prefetto Rustico pronunziò la sentenza dicendo: «Coloro che non hanno voluto sacrificare agli dèi e ubbidire all’ordine dell’imperatore, dopo essere stati flagellati siano condotti via per essere decapitati a norma di legge». I santi martiri glorificando Dio, giunti al luogo solito, furono decapitati e portarono a termine la testimonianza della loro professione di fede nel Salvatore.
IL DIALOGO CON TRIFONE
Nel panorama della prima letteratura cristiana questa è indubbiamente un’opera nuova e innovativa. Dato che Trifone è un personaggio appartenente al mondo ebraico, ci si immagina che qui si crei un dibattito tra cristiani ed ebrei, con lo scopo di mettere in campo le basi comuni e nel contempo anche le profonde differenze. Qui il dialogo è piuttosto un genere letterario molto di moda nell’antichità e tipico delle questioni di natura filosofica, con cui si mettevano in campo i diversi orientamenti, per-ché i lettori operassero poi le loro scelte.
16
Giustino non dovrebbe avere come scopo quello di convincere il suo interlocutore a lasciare la propria fede e aderire a quella nuova. Se teniamo presente che Giustino è originario della Palestina, anche a non essere ebreo, dovremmo pensare che egli conosca bene quel mondo e che cerchi di contribuire al recupero di questa gente, tenuto conto che essa stava vivendo un momento particolarmente difficile: sotto la cenere della distruzione del 70 covava il risentimento verso il mondo romano, sempre più stanco delle rivolte in corso. Diversa-mente dalle Apologie dove la contrapposizione con il mondo pagano è tale da generare una persecuzioni pregiudiziale fino ad un giudizio di condanna inappellabile, qui non emerge la presa di distanza nei confronti del mondo giudaico, affiorata con le prime incomprensioni e soprattutto con il rischio corso dai cristiani di essere associati agli Ebrei nel comune disprezzo. Qui si tenta di trovare fra cristiani ed ebrei una base comune.
Il tema è il confronto con il giudaismo, con il quale i cristiani avevano in comune l’Antico Testamento, un terreno utile per un dialogo. Si tratta di un dibattito che si svolge ad Efeso nell’arco di due giorni e vede protagonisti Giustino e Trifone, nel quale è stata individuata da alcuni storici la personalità di un rabbino realmente esistito. Lo scopo di questo dialogo è mostrare la verità del cristianesimo, rispondendo alle principali obiezioni mosse dagli ambienti giudaici. In particolare, Giustino vuole dimostrare che il culto di Gesù non mette in discussione il monoteismo e che le profezie descritte nell’Antico Testamento si siano avverate con l’avvento di Cristo. Il dialogo assume toni sempre rispettosi e amichevoli e non si conclude, com’era consuetudine per gli scritti cristiani, con la richiesta da parte del giudeo del battesimo. A tal proposito, alcuni studiosi si sono chiesti se effettivamente le motivazioni portate avanti da Giustino in questo dialogo fossero valide a convertire un giudeo. Sembra piuttosto verosimile, invece, che quest’opera sia una risposta di Giustino ai dubbi che i cristiani stessi del tempo nutrivano verso la loro fede. (Wikipedia)
Prevale di fatto una lettura di quest’opera che lascia trasparire una certa diffidenza con il mondo ebraico, anche se il dialogo avviene con metodi rispettosi dell’interlocutore ed argomenti razionali che vogliono fare appello al buon senso. Le interpretazioni successive, soprattutto da parte ebraica, mettono in luce una netta presa di distanza dentro il filone delle opere di provenienza cristiana, che non si rivelano accomodanti con l’ebraismo. E allora il dialogo è solo una formula letteraria, non un serio confronto di idee fra mondi diversi, che sembrano incomunicabili …
17
Il confronto con il giudaismo fu ovviamente una delle dinamiche di crescita del cristianesimo fin dalle sue origini (già il vangelo di Matteo è un’apologia del cristianesimo nei confronti del giudaismo), ma il problema per noi è di conoscere la situazione al tempo di Giustino, dopo che, in particolare, le catastrofi del 70 e del 135 avevano del tutto frantumato l’unità nazionale giudaica. (…) I Cristiani d’altra parte denunciano un atteggiamento persecutorio da parte dei giudei, che ha una vivida eco nel nostro Dialogo; se Trifone accenna a una proibizione, da parte dei rabbini, ad avere contatti con i cristiani, Giustino parla di maledizioni contro questi ultimi inserite nella preghiera sinagogale e di persecuzioni ordite a danno dei cristiani dai giudei, i quali anzi con le loro calunnie sarebbero la causa prima delle persecuzioni inflitte dai pagani. (,,,) Gran parte della relativa letteratura era destinata ai cristiani e non ai giudei e mirava non a convincere e a recuperare il giudeo ma a schiacciarlo, in un confronto polemico fittizio ad uso interno, per salvaguardare i cristiani dalla propaganda giudaica e dalle ricorrenti tentazioni di riflusso verso il giudaismo. (…) Il dialogo appare un puro artificio letterario e Trifone risulta essere un “uomo di paglia”, un personaggio di comodo storicamente non credibile, che ha l’unica funzione di offrire il destro alle tesi cristiane. Non un dialogo, quindi, ma un monologo, una imposizione di un punto di vista unilaterale, attuata in modo più sottile, per non dire subdolo, grazie alla parvenza di un libero confronto da pari a pari. Vista così, questa letteratura cessa di essere un dialogo anche in quanto non è rivolta ai giudei, ma sono le loro difficoltà che essa si propone di risolvere, non è la loro con-versione che essa ha a cuore, ma si parla al giudeo perché senta il cristiano (o il pagano).
(Visonà p. 49-53)
Già le prime battute dl dialogo dove i due interlocutori si presentano si rivela la loro impostazione che non potrà avere modifiche nel corso del dialogo, dove prevale evidentemente la tesi cristiana di Giustino nella illusione che possa bastare il suo argomentare a convincere i lettori.
Un fuoco divampò nel mio animo e mi pervase l’amore per i profeti e per quegli uomini che sono amici di Cristo. Ponderando tra me e me le sue parole trovai che questa era l’unica filosofia certa e proficua. In questo modo e per queste ragioni io sono un filosofo, e vorrei che tutti assumessero la mia stessa risoluzione e più non si allontanassero dalle parole del Salvatore. Esse infatti incutono un certo timore e sono sufficienti a confondere coloro che deviano dalla retta via, mentre una quiete dolcissima pervade coloro che le mettono in pratica. Se dunque anche tu hai a cuore il tuo destino e reclami salvezza e hai fiducia in Dio – e se non ti senti indifferente al problema – hai la possibilità, una volta riconosciuto il Cristo di Dio e conseguita una completa iniziazione, di raggiungere la felicità.
18
Come ebbi detto queste cose, carissimo, i compagni di Trifone scoppiarono a ridere, mentre lui sorrideva tra sé e diceva:
Accetto il resto di quanto hai detto e apprezzo il tuo slancio per il divino, ma forse era meglio se continuavi a esercitarti con la filosofia di Platone o di qualche altro filosofo, praticando la fortezza, la temperanza e la sapienza, piuttosto che farti traviare da simili fandonie e seguire uomini che non sono degni di nessuna considerazione. Finché infatti rimanevi in quel tipo di filo-sofia e conducevi una vita irreprensibile ti restava la speranza di un destino migliore, ma una volta abbandonato Dio e riposta la speranza in un uomo (che è naturalmente Gesù di Nazaret assolutamente non riconosciuto come Dio) quale mai salvezza puoi ancora sperare? Se vuoi prestare ascolto anche a me (ché ti considero ormai un amico) comincia col farti circoncidere, poi osserva, secondo l’uso, il sabato, le feste e i noviluni sacri a Dio, insomma, osserva tutto ciò che è scritto nella Legge e forse troverai misericordia presso Dio. Quanto al Cristo, se mai è nato ed esiste da qualche parte, è sconosciuto e non ha coscienza di sé né potenza alcuna fintanto che non venga Elia ad ungerlo e a manifestarlo a tutti. Voi, invece, raccogliendo una vuota diceria, vi siete fatti un vostro Cristo e a causa sua ora state andando cieca-mente alla rovina. (Dialogo 8)
Probabilmente non c’è stato il tempo per una revisione del testo, dove gli argomenti procedono sulla base di una certa foga argomentativa. Ci sono comunque i tempi cari della polemica antigiudaica in riferimento all’Antico Testamento, che non viene rifiutato, ma che è comunque ritenuto, come la Legge, “pedagogo a Cristo”. Ovviamente deve apparire che al centro ci sia proprio il Cristo, respinto dai Giudei e nel contempo la realtà del Nuovo Israele, rappresentato dalla Chiesa. La sua operazione non risulta comunque credibile e soddisfacente, se non perché egli rivela di citare bene i testi biblici che ha a disposizione, compresi quelli che riguardano il Nuovo Testamento, da poco emerso per iscritto dopo una fase orale. Per quanto egli voglia apparire come un intellettuale con buone doti di filosofo, e insieme rivelare conoscenze di natura teologica, il suo lavoro è ancora acerbo e richiede maggior profondità. Tuttavia è già indicato il percorso di un “dialogo” con le realtà che il mondo cristiano ha davanti a sé per un confronto ineludibile.
Giustino tenta una grande operazione: situare e unificare nel mistero di Cristo la sapienza pagana e la fede giudaica.
19
Il Verbo Cristo è la pienezza di ciò che è presente come seme nella prima e come figura nella seconda, così che il Cristianesimo diventa la vera Filosofia e il nuovo Israele. Forse i mezzi non sono adeguati all’intento. Giustino è stato giudicato un mediocre come filosofo, come teologo, come esegeta, come scrittore. In parte è vero: il suo pensiero non è rigoroso, la sua speculazione teologica non è sopraffine, la sua esegesi è impacciata e il suo greco assolutamente scadente. È facile sotto-valutare Giustino e perdere così la corposità del suo contributo, che è un contributo di sostanza che fa forza sui suoi limiti personali, al di sotto dei quali recuperiamo un patrimonio di fede su Dio, la creazione, l’incarnazione, la redenzione, la Chiesa, il battesimo, l’eucarestia, l’escatologia, di una ricchezza e di una saldezza quale è sorprendente trovare in un unico autore della prima metà del II secolo. (Visonà p. 70)
CONCLUSIONE
In una presentazione a volte sommaria di quest’uomo e dei suoi scritti, si insiste all’eccesso sul fatto che siamo in presenza del primo intellettuale cristiano: certamente così voleva essere inteso anche lui. È indubbiamente un primo tentativo di andare oltre il solito proselitismo che faceva presa nella gente comune, per offrire una immagine della nuova religione che cerca di penetrare anche negli ambienti finora negati persino da una certa supponenza dei circoli culturali dell’epoca. Giustino cerca un contatto, per quanto non appaia adatto e sufficiente. È comunque necessario che ci si muova in questa direzione, sia da parte di certa letteratura e filosofia, sia da parte del mondo cristiano, talvolta rinchiuso nei propri schemi e in certi intendimenti dottrinari da esibire senza alcuna discussione. Qui si apre la strada, anche se forse ancora non è chiaro il metodo e neppure sono chiariti i contenuti da offrire per tenere aperto il dialogo. Esso è ancora oggi faticoso, quando prevale la pretesa dottrinaria da imporre o il pregiudizio di chi nega la possibilità di una reale discussione, se la fede e la ragione sono dissociate come realtà inconciliabili. Non si è veri credenti senza la ragione; ma anche certo razionalismo freddo, che rifiuta a priori gli atti di fiducia, pure loro essenziali nel vivere umano, non può fare a meno della fede. Il dibattito sull’argomento rimane vivo e aperto e deve richiedere anche oggi un dialogo aperto e sincero. Va riconosciuto a Giustino lo sforzo sincero di entrare in comunicazione con un mondo che si presenta ostile verso chi aderisce alla fede cristiana. Poi però la forma apologetica e quella di un dialogo unidirezionale non si rivelano adeguati ad entrare in una comunicazione che vuole servire la Verità …
20

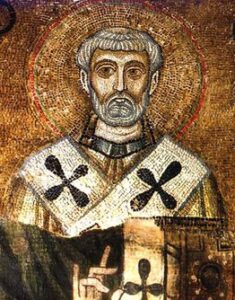
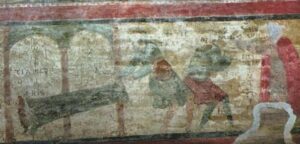
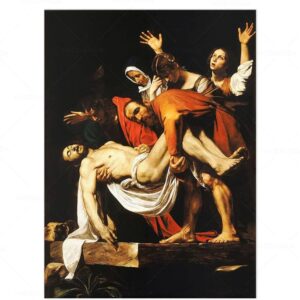




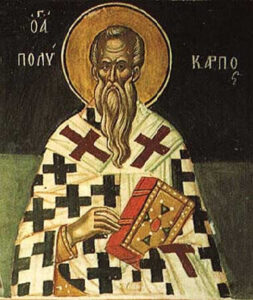
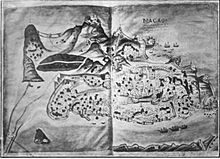 …
…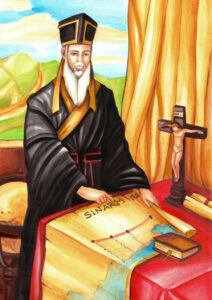
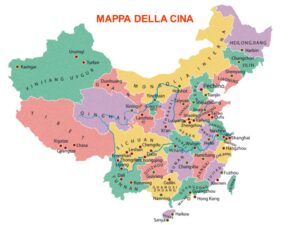

 Il fascismo è abbinato alla dittatura, perché di fatto essa si è realizzata in Italia con gli uomini che venivano da quel partito e da quella impostazione, come pure dall’uso della violenza fisica, che in realtà non era un fenomeno e un mezzo gestiti in maniera esclusiva da quel partito. Del resto anche la forma dittatoriale di potere e di occupazione del governo non può essere considerato un obiettivo da raggiungere perseguito solo da quel partito, anche se per l’Italia, gli anni della dittatura hanno visto il fascismo dominare la scena politica. Eppure, come stanno a testimoniare gli inizi del governo di Mussolini, anche se il ricorso alla violenza non è mancato, anche se i progetti e i metodi usati facevano presagire un esito che conduceva verso il totalitarismo, i primi passi non possono essere considerati già manifestazione di un esercizio del potere in forma dittatoriale. Del resto qualcuno ancora sperava che il fascismo potesse essere assorbito dal sistema parlamentare, una volta fatto entrare in esso: anche i partiti di sinistra, i più ferocemente avversi al fascismo e all’uomo che lo rappresentava, non immaginavano che esso potesse prosperare, in presenza di elezioni che vedevano le forze di sinistra aumentare il numero dei loro rappresentanti, per quanto ancora in maniera insufficiente. Mussolini stesso era consapevole, che a ricercare il consenso popolare mediante le elezioni, non poteva coltivare la prospettiva di venirne fuori vincente, se non cambiando e adeguando ai suoi obiettivi la legge elettorale. Per questo motivo elaborò la Legge Acerbo, e con essa poté vincere le elezioni, senza per questo avere di fatto una Camera, in cui ci fosse un unico partito: solo così la Camera poteva essere esautorata e resa perfettamente inutile. Proprio nell’immediato periodo successivo alle elezioni si consumò la trasformazione, da parte di Mussolini, dello Stato italiano da regno costituzionale a dittatura di fatto. Dobbiamo definirla così, perché in realtà, almeno formalmente venne mantenuto lo Statuto albertino e l’Italia rimaneva ancora una monarchia: il Capo dello Stato era il Re, non il Duce; ma il Capo del governo, pur nominato dal Re, gestiva il potere in modo assoluto e senza limiti particolari, se non quello di avere una figura superiore, il sovrano, che era a capo delle forze armate. Si potrebbe parlare di una sorta di diarchia, che comunque risultava vantaggiosa per il capo del governo. I partiti, minoritari inizialmente nel Parlamento, per essere poi del tutto aboliti, speravano di poter trovare nel sovrano un punto di appoggio, a garanzia, non solo formale, dello Statuto; ma dal Re non venne a loro alcun appoggio, se non nel momento più drammatico della storia italiana, quando con la guerra ormai persa, si doveva uscirne in maniera dignitosa.
Il fascismo è abbinato alla dittatura, perché di fatto essa si è realizzata in Italia con gli uomini che venivano da quel partito e da quella impostazione, come pure dall’uso della violenza fisica, che in realtà non era un fenomeno e un mezzo gestiti in maniera esclusiva da quel partito. Del resto anche la forma dittatoriale di potere e di occupazione del governo non può essere considerato un obiettivo da raggiungere perseguito solo da quel partito, anche se per l’Italia, gli anni della dittatura hanno visto il fascismo dominare la scena politica. Eppure, come stanno a testimoniare gli inizi del governo di Mussolini, anche se il ricorso alla violenza non è mancato, anche se i progetti e i metodi usati facevano presagire un esito che conduceva verso il totalitarismo, i primi passi non possono essere considerati già manifestazione di un esercizio del potere in forma dittatoriale. Del resto qualcuno ancora sperava che il fascismo potesse essere assorbito dal sistema parlamentare, una volta fatto entrare in esso: anche i partiti di sinistra, i più ferocemente avversi al fascismo e all’uomo che lo rappresentava, non immaginavano che esso potesse prosperare, in presenza di elezioni che vedevano le forze di sinistra aumentare il numero dei loro rappresentanti, per quanto ancora in maniera insufficiente. Mussolini stesso era consapevole, che a ricercare il consenso popolare mediante le elezioni, non poteva coltivare la prospettiva di venirne fuori vincente, se non cambiando e adeguando ai suoi obiettivi la legge elettorale. Per questo motivo elaborò la Legge Acerbo, e con essa poté vincere le elezioni, senza per questo avere di fatto una Camera, in cui ci fosse un unico partito: solo così la Camera poteva essere esautorata e resa perfettamente inutile. Proprio nell’immediato periodo successivo alle elezioni si consumò la trasformazione, da parte di Mussolini, dello Stato italiano da regno costituzionale a dittatura di fatto. Dobbiamo definirla così, perché in realtà, almeno formalmente venne mantenuto lo Statuto albertino e l’Italia rimaneva ancora una monarchia: il Capo dello Stato era il Re, non il Duce; ma il Capo del governo, pur nominato dal Re, gestiva il potere in modo assoluto e senza limiti particolari, se non quello di avere una figura superiore, il sovrano, che era a capo delle forze armate. Si potrebbe parlare di una sorta di diarchia, che comunque risultava vantaggiosa per il capo del governo. I partiti, minoritari inizialmente nel Parlamento, per essere poi del tutto aboliti, speravano di poter trovare nel sovrano un punto di appoggio, a garanzia, non solo formale, dello Statuto; ma dal Re non venne a loro alcun appoggio, se non nel momento più drammatico della storia italiana, quando con la guerra ormai persa, si doveva uscirne in maniera dignitosa.