PERSONAGGI IN CERCA D’AUTORE
L’idea del romanzo derivò dunque da un cronista e da un economista, fonti del tutto degne di un tenace illuminista. E fu in quelle pagine ch’egli scoprì una grida sui matrimoni impediti. Questo matrimonio contrastato sarebbe stato per lui un buon soggetto per un romanzo, che avrebbe avuto come finale grandioso la peste “che aggiusta ogni cosa”. Così prima di pensare agli avvenimenti e ai personaggi, egli intendeva fissare con sicurezza le condizioni economiche, civili e politiche di un popolo, nella prima metà del XVII secolo. Sino al 1821 Manzoni non parlava che di liriche e di tragedie. Al ritorno da un viaggio a Parigi, pensa sì all’Adelchi, ma l’idea del romanzo si fa più insistente. Non può togliersi dalla testa la lettura di quelle grida, le figure di quei bravi. Nell’aprile del 1821 si mette a scrivere e informa quasi periodicamente il Fauriel dei progressi del suo lavoro. E furono due anni percorsi da una strana forma di allegria, quale non aveva mai provato. Furono insomma gli anni più felici della sua vita. E confesserà al suo amico e parente, il Giorgini (suo genero, avendo sposato la figlia di Manzoni, Vittoria), che alzarsi ogni mattino con le immagini vive del giorno innanzi alla mente, scendere nello studio, tirar fuori dal cassetto dello scrittoio qualcuno di quei soliti personaggi, disporli davanti a sé come tanti burattini, osservarne le mosse, ascoltarne i discorsi, poi mettere in carta e rileggere, era un godimento così vivo come quello di una curiosità soddisfatta. Sembra quasi sentire Pirandello dinanzi ai suoi personaggi, giulivo, anche se la materia che trattava fosse nera e dolorosa. (Macchia, p. 50-52)
Indubbiamente la prima redazione del romanzo, come già detto, avviene “di getto”, come se la materia stessa urgesse dal di dentro e richiedesse un frenetico lavoro di scrittura, come forse non gli era mai capitato di fare. Questa maniera di operare, ben descritta nelle parole citate, dice da una parte che lo scrittore sente l’urgenza di scrivere, anche se poi tutto quel materiale che preme dal di dentro richiede una rilettura che permetta di avere maggior padronanza. Più che di personaggi “eroici” , come potevano essere quelli delle sue tragedie, anche per la natura stessa di quelle opere, legate ad un’epoca, ormai tramontata, qui avvertiva la necessità di creare una storia più … corale, secondo la sperimentazione fatta nelle tragedie stesse. Lì, oltre le scene che danno spazio a figure di grande risalto “tragico”, Manzoni parla di un popolo (“un volgo disperso che nome non ha”), chiamato ad avere un ruolo nella grande storia, raggiunto non senza prove e traversie. Nel contempo questo popolo è rappresentato con individualità ben precise: sono i nuovi eroi presi dalla vita comune e destinati ad avere la propria parte nel grande scenario storico.
Tutta questa materia, mai finora messa in scena, richiede che l’autore ne abbia la padronanza e che dunque lui pure si metta in gioco dentro la storia che è sua, tutta sua. Nel contempo – come succederà poi a Pirandello – è in cerca di chi la sappia far uscire dall’oscurità e farla diventare “magistra vitae”, come dovrebbe essere. Nel costruire la vicenda principale, non l’ unica, di questa grande storia corale, spesso i personaggi stessi finiscono per sfuggire e cercare uno spazio più allargato, come se avessero una storia a parte e cercassero una propria autonomia, quella che poi si traduce concretamente in una digressione dal corso degli eventi. In effetti nel “Fermo e Lucia” alcune figure assumono un rilievo tale da costituire personaggi che possono anche stare a parte del filone principale. Anche nella redazione finale i medesimi personaggi hanno uno spazio adeguata; ma di fatto risultano ridimensionati per poter servire la storia in cui sono inseriti e non invece servirsi della medesima storia per cercare una propria visibilità. Ma anche la difficoltà a padroneggiare l’intera materia dà l’occasione per una riflessione ulteriore che consente allo scrittore di divenire lui il regista di una materia magmatica, da comporre in maniera armonica perché ne venga non solo un capolavoro letterario, ma anche un buon metodo di studio e di analisi della storia e delle persone. Qui c’è ancora un materiale grezzo; e lo scrittore se ne rende conto, appena dà alla luce la sua opera. Su questa consapevolezza costruisce quella revisio-ne che porterà a qualcosa di assolutamente nuovo e davvero differente rispetto all’originale.
LO SCRITTORE COME PERSONAGGIO
Va pure precisato che dentro la vicenda dei due giovani si aggira un personaggio nascosto, e cioè l’autore stesso. Manzoni appare sempre più coinvolto per il fatto che fin dall’inizio egli si presenta schermendosi di non essere propriamente l’autore della storia, per il fatto che gli episodi da cui parte gli sono forniti dai suoi autori di riferimento, e più ancora dal documento già redatto in una lingua che non farebbe essere moderna quella storia pur interessante. Ovviamente il documento non esiste; è solo una sua invenzione, così come lo è questo scrupolo di trovare una lingua adeguata. Tale cura rimarrà costante fino alla redazione finale.
Nella vicenda, comunque, egli spesso entra – e altrettanto sarà, in modo più ridotto, anche in alcuni momenti della redazione finale – e la sua partecipazione ha la medesima funzione del coro delle tragedie, quella cioè di suggerire una sorta di “morale” del racconto stesso, quasi a guidare per mano il lettore, che travolto dalle vicende stesse non ha la capacità e la cura di soffermarsi a riflettere.
Il romanziere Manzoni, questo strano personaggio che pareva non aver diritto d’ingresso nelle nostre patrie lettere, nasceva dunque in un paesaggio desertico e sconvolto. Da una parte la sterile landa del romanzo italiano, e dall’altra le rovine pur gloriose della propria esperienza di poeta tragico ch’egli, dopo l’Adelchi e dopo un tentativo non riuscito di un’altra tragedia, Spartaco, improvvisamente abbandonava. E ancora di più colpisce il silenzio del poeta lirico, esperienza interrotta perché, confesserà, egli non poteva correr dietro a una Musa che gli sfuggiva. La religione, educata ai grandi tetri esempi della cultura giansenista, non gli offriva, si è detto, alcun conforto. Il passato, per quel che apparteneva alla storia degli uomini, gli rivelava il suo aspetto tremendo, fatto di dolori, di crudeltà, di sopraffazioni, in cui, tra prepotenze, guerre e carestie, erano sempre gli altri, gli innocenti, a pagare. Ma la meditazione sui fatti della storia non poteva uccidere il creatore ch’era in lui, il creatore che già nella tragedia aveva dato vita a grandi personaggi, quasi isolati dalla realtà della loro gente. Dopo la sconfitta di quei personaggi, dopo la morte dell’“eroe”, egli cominciò ad avvertire che “il muro di parole solenni” rappresentato dal coro, dov’era descritto liricamente il quadro desolante delle condizioni del popolo, dovesse essere portato sulla scena. (Macchia, p. 52-52)
Così troviamo anche lo scrittore come personaggio della storia narrata. Ci sono diverse sue “incursioni”, che naturalmente appesantiscono il lavoro. Manzoni stesso se ne rende conto ed avverte il lettore di passare oltre, se lo attrae la vicenda e non vuole perdersi dentro le sue osservazioni. D’altra parte, per il modo con cui ha assimilato la lezione di storia e soprattutto la vuole far conoscere, si rende conto della necessità di queste sue “sortite” che hanno l’intento di avviare il lettore alla comprensione della Storia, intesa proprio come “maestra di vita”. All’inizio del Tomo II – il romanzo è suddiviso in quattro tomi – c’è una lunga digressione che vede come protagonista il narratore nel suo intento di chiarire il senso della storia, non in riferimento alla vicenda verosimile, quanto piuttosto al modo con cui ciascuno deve porsi, se vuole essere – come è giusto che sia – un vero protagonista nello scorrere del tempo.
Avendo posto in fronte a questo scritto il titolo di storia, e fatto creder così al lettore ch’egli troverebbe una serie continua di fatti, mi trovo in obbligo di avvertirlo qui, che la narrazione sarà sospesa alquanto da una discussione sopra principj; discussione la quale occuperà probabilmente un buon terzo di questo capitolo. Il lettore che lo sa potrà saltare alcune pagine per riprendere il filo della storia: e per me lo consiglio di far così: giacché le parole che mi sento sulla punta della penna sono tali da annojarlo, o anche da fargli venir la muffa al naso. (Fermo e Lucia, Tomo II, Cap. I, p. 143)
Qui, ovviamente, non si ha quella forma di intervento a cui ci ha abituati nei cori delle tragedie. Qui si tratta solo dell’avvertenza al lettore circa la necessità di far capire che la storia non si ha solo con il susseguirsi di episodi che sono l’elemento portante della narrazione. La storia, invece, quella che non è costituita dai soli fatti e dalle date, è piuttosto un lavoro di riflessione sugli eventi, come giustamente e sempre si dovrebbe fare. Per lui una storia d’amore, come è quella narrata, risulta veramente tale, quando passa da traversie, nelle quali matura un vivere più fedele e pro-prio per questo migliore …
— Armatevi di pazienza, ed ascoltate. Se io potessi fare in guisa che questa storia non capitasse in mano ad altri che a sposi innamorati, nel giorno che hanno detto e inteso in presenza del parroco un sì delizioso, allora forse converrebbe mettervi quanto amore si potesse poiché per tali lettori non potrebbe certamente aver nulla di pericoloso. Penso però, che sarebbe inutile per essi, e che troverebbero tutto questo amore molto freddo, quand’anche fosse trattato da tutt’altri che dal mio autore e da me; perché quale è lo scritto dove sia trasfuso l’amore quale il cuor dell’uomo può sentirlo? Ma ponete il caso, che questa storia venisse alle mani per esempio d’una vergine non più acerba, più saggia che avvenente (non mi direte che non ve n’abbia), e di anguste fortune, la quale perduto già ogni pensiero di nozze, se ne va campucchiando, quietamente, e cerca di tenere occupato il cuor suo coll’idea dei suoi doveri, colle consolazioni della innocenza e della pace, e colle speranze che il mondo non può dare né torre; ditemi un po’ che bell’acconcio potrebbe fare a questa creatura una storia che le venisse a rimescolare in cuore quei sentimenti, che molto saggiamente ella vi ha sopiti. Ponete il caso che un giovane prete il quale coi gravi uficj del suo ministero, colle fatiche della carità, con la preghiera, con lo studio, attende a sdrucciolare sugli anni pericolosi che gli rimangono da trascorrere, ponendo ogni cura di non cadere, e non guardando troppo a dritta né a sinistra per non dar qualche stramazzone in un momento di distrazione, ponete il caso che questo giovane prete si ponga a leggere questa storia: giacché non vorreste che si pubblicasse un libro che un prete non abbia da leggere: e ditemi un po’ che vantaggio gli farebbe una descrizione di quei sentimenti ch’egli debbe soffocare ben bene nel suo cuore, se non vuole mancare ad un impegno sacro ed assunto volontariamente, se non vuole porre nella sua vita una contraddizione che tutta la alteri. Vedete quanti simili casi si potrebber fare. Concludo che l’amore è necessario a questo mondo: ma ve n’ha quanto basta, e non fa mestieri che altri si dia la briga di coltivarlo; e che col volerlo coltivare non si fa altro che farne nascere dove non fa bisogno. Vi hanno altri sentimenti dei quali il mondo ha bisogno, e che uno scrittore secondo le sue forze può diffondere un po’ più negli animi: come sarebbe la commiserazione, l’affetto al prossimo, la dolcezza, l’indulgenza, il sacrificio di se stesso: oh di questi non v’ha mai eccesso; e lode a quegli scrittori che cercano di metterne un po’ più nelle cose di questo mondo: ma dell’amore come vi diceva, ve n’ha, facendo un calcolo moderato, seicento volte più di quello che sia necessario alla conservazione della nostra riverita specie. Io stimo dunque opera imprudente l’andarlo fomentando cogli scritti; e ne son tanto persuaso; che se un bel giorno per un prodigio, mi venissero ispirate le pagine più eloquenti d’amore che un uomo abbia mai scritte, non piglierei la penna per metterne una linea sulla carta: tanto son certo che me ne pentirei. (Fermo e Lucia, Tomo II, Cap. I, p. 144-5)
Essendo dunque una storia d’amore – e questa viene narrata cosicché tutti possono leggere e usufruirne – occorre trattarne in modo che di lì se ne abbia per tutti una lezione di vita. Ma questo deve valere anche per altri sentimenti o stati d’animo: è bene che siano non solo vissuti, ma anche, come esperienze di vita, che possano diventare mezzi e insegnamenti per un vivere davvero più umano. La letteratura non può essere considerata un “ozio”, come si vuol intendere a partire dal vocabolo latino “otium”, con cui viene designato ogni forma di studio e di impegno del pensiero; essa deve prefiggersi pure l’“utile” che se ne trae e che un po’ troppo sbrigativamente può essere considerata la morale … Manzoni si sofferma su queste considerazioni poco prima di affrontare una diversa storia d’amore, come è quella della monaca di Monza, che appare non così nobile, come la storia dei due poveri contadini, anche vissuta da una donna d’alto lignaggio. Anche questa, che interseca la vicenda dei due protagonisti, rimasti “sposi promessi”, è pur sempre storia d’amore.
LA MONACA DI MONZA
 Il personaggio di Gertrude è presente nelle tre redazioni della storia; e tuttavia quella sorta di compiacimento per quanto di lubrico emerge da una simile vicenda si attenua, come pure si ridimensionano i dettagli, per dare lo spazio giusto ad una figura decisamente importante per lo sviluppo della vicenda centrale. Se nel “Fermo e Lucia”, non solo si ha la digressione che riguarda la forzata monacazione della donna, ma si aggiunge anche tutta la tresca con il “suo” Egidio fino all’assassinio della conversa, ne “I Promessi Sposi” possono bastare le famose parole: “E la sventurata rispose”, perché tutti i dettagli delle trame più oscure siano solo fatte intuire, senza il compiacimento del narrarle. In genere chi commenta le pagine della storia della monaca di Monza deve registrare un certo interesse per i particolari di una storia libertina. L’autore sarà richiamato dagli amici a porvi mano per tenere a bada e fors’anche per mettere da parte una vicenda dalle fosche tinte. Indubbiamente c’è una notevole riduzione; ma la storia della monaca non viene messa da parte, anche se essa appare una vicenda collaterale, la quale avrebbe potuto seguire uno sviluppo autonomo che ne avrebbe fatto una vicenda a parte.
Il personaggio di Gertrude è presente nelle tre redazioni della storia; e tuttavia quella sorta di compiacimento per quanto di lubrico emerge da una simile vicenda si attenua, come pure si ridimensionano i dettagli, per dare lo spazio giusto ad una figura decisamente importante per lo sviluppo della vicenda centrale. Se nel “Fermo e Lucia”, non solo si ha la digressione che riguarda la forzata monacazione della donna, ma si aggiunge anche tutta la tresca con il “suo” Egidio fino all’assassinio della conversa, ne “I Promessi Sposi” possono bastare le famose parole: “E la sventurata rispose”, perché tutti i dettagli delle trame più oscure siano solo fatte intuire, senza il compiacimento del narrarle. In genere chi commenta le pagine della storia della monaca di Monza deve registrare un certo interesse per i particolari di una storia libertina. L’autore sarà richiamato dagli amici a porvi mano per tenere a bada e fors’anche per mettere da parte una vicenda dalle fosche tinte. Indubbiamente c’è una notevole riduzione; ma la storia della monaca non viene messa da parte, anche se essa appare una vicenda collaterale, la quale avrebbe potuto seguire uno sviluppo autonomo che ne avrebbe fatto una vicenda a parte.
La storia di Gertrude costituisce l’episodio più celebre di tutti i Promessi Sposi. (…) La storia di Gertrude fu attinta, come altre del romanzo dalla Historia Patria del canonico Giuseppe Ripamonti. Si tratta anzi di uno di quei casi in cui lo scrittore rinvia direttamente alla sua fonte. Soltanto successivamente all’edizione del 1827 Manzoni poté consultare anche gli atti del processo cano-nico alla monaca promosso dal cardinale Federico Borromeo nel 1607. (…) Gertrude è il primo personaggio storico introdotto nel romanzo, il primo per il quale Manzoni dovesse porsi concretamente il problema del rapporto fra storia e immaginazione. Di fronte alla sua fonte si comportò con una certa libertà, pur rispettando sostanzialmente gli elementi principali della vicenda originale. Prima di tutto tacque il vero nome di Gertrude e della sua famiglia, quella spagnola dei de Leyva: “sebbene sia estinta da un pezzo, ci par meglio lasciarlo nella penna, per non metterci a rischio di far torto neppure ai morti, e per lasciare ai dotti qualche soggetto di ricerca”. (…) Si concentrò unicamente sulla vicenda psicologica della monaca, trascurando le vicissitudini del suo amante, responsabile di tutta una serie di delitti, oltre a quello dell’ucci-sione della conversa raccontato anche da Manzoni, tutti causati dalla neces-sità di nascondere la relazione peccaminosa con suor Virginia o i successivi omicidi. Accennò soltanto di sfuggita, alla fine del romanzo, alla condanna subita dalla Signora di Monza e alla reclusione nel convento di Santa Maria Valeria a Milano a opera soprattutto del cardinale Borromeo”. (Suitner, p.119-120)
Nel Fermo e Lucia la storia di questa monaca ha un’estensione notevole, perché, dei nove capitoli del Tomo II, ben sei vedono la presenza e l’azione, nefanda, di questa suora, che all’inizio dà il titolo al primo capitolo con l’espressione “La Signora”. Il nome tutto fa pensare, ma non certo ad una religiosa, che del resto abita un monastero di clausura. Con questo nome rimane anche nell’edizione finale, per quanto questa non preveda i titoli nei singoli capitoli. Nella prima edizione tutta la storia è scandagliata in ogni suo particolare, mentre nella seconda spariscono le notizie più pruriginose, legate ai rapporti clandestini con l’amante, e soprattutto le tresche, non solo amorose, ma più ancora omicide che accompagnano e seguono questi incontri per nulla edificanti. Manzoni interviene anche dietro sollecitazione degli amici, e soprattutto del canonico Tosi, il quale lo aveva seguito nella formazione cattolica, sul versante giansenista, dopo la conversione: non gli poteva affatto piacere quella storia nella storia, che appariva del resto fuori luogo e nient’affatto necessaria alla comprensione della vicenda principale.
Le motivazioni che hanno condotto Manzoni a queste modifiche sono oggetto da sempre di ampia discussione … I primissimi lettori del manoscritto manzoniano sollevarono delle obiezioni, e addirittura alcuni ne avrebbero desiderato la soppressione. Monsignor Tosi era del parere di eliminarlo per motivi religiosi. Claude Fauriel per motivi estetici, essendo la storia della monaca una sorta di “romanzo nel romanzo” che deviava l’interesse dei lettori dalla vicenda principale … (eppure) l’episodio della monaca di Monza non fu affatto cancellato dal romanzo, ma soltanto corretto e riscritto. (Suitner, p.121)
E tuttavia non fu così facile operare neppure questa sorta di autocensura, perché egli non riteneva disdicevole trattare di scene così “forti”, sul piano emotivo e morale, perché la stessa conoscenza del male può considerarsi “istruttiva”, come lui stesso sostiene, dentro una vicenda ancora più complessa, nella quale il male ha un suo ampio operare. Anch’egli dibatte nella “Lettre à M. Chauvet” la questione del “vero” che va rappresentato anche in questi casi, così come ancora oggi si discute ampiamente circa la necessità che ogni dettaglio di tragedie consumate nel sangue, debba essere ben descritto a motivo della verità giornalistica.
E così neppure per lui è stato facile operare una simile scelta, tenuto conto che poi vi si adatta, ma sembrerebbe più per ragioni estetiche che non per motivazioni etiche. E le medesime considerazioni vanno fatte a proposito del tema dell’amore, che se in Virginia ed Osio, o Gertrude ed Egidio, presenta aspetti passionali, in Fermo e Lucia, o Renzo e Lucia, va collocato sul versante di un vero e proprio idillio positivo. Da qualche parte si rimprovera a Manzoni di non aver sufficientemente fatto emergere gli stati d’animo dei due sposi, sempre promessi, con il loro percorso sentimentale, che del resto dovrebbe essere la ragione più profonda di questo amore, pur contrastato. Sembra quasi che se Manzoni arriva a dominarsi con la storia dei due diabolici amanti, per espungerla dal suo romanzo, altrettanto si trattiene dall’esprimere qualcosa circa la bella storia d’amore dei due protagonisti, limitandosi ad accennare al pudico rossore di lei. Del resto Manzoni stesso, come s’è visto sopra, nella digressione che antepone al capitolo I del secondo tomo, afferma con molta chiarezza che “non si deve scrivere d’amore in modo da far consentire l’animo di chi legge a questa passione”, perché vi sono ben altri sentimenti da segnalare, considerati molto più utili al vivere sociale.
Queste pagine sono assai importanti e andrebbero commentate più ampiamente di quanto qui è possibile fare, anche perché non ci offrono solo una chiave per capire un aspetto della rinuncia manzoniana ai brani riguardanti gli amori di Gertrude ed Egidio, ma spiegano almeno in parte anche la reticenza sulle passioni di Renzo e Lucia, così spesso rimproverata a Manzoni. Come penso si sia capito dalle citazioni, lo scrittore ha nutrito diverse preoccupazioni, e le sue affermazioni su questi problemi sono un po’ oscillanti. Si trattava di conciliare la verità e la morale. Ora pare che la descrizione dell’amore vada limitata proprio per riguardo alla verità, in quanto questo sentimento non occupa nella vita reale quello spazio che i poeti gli vogliono concedere. Ora paiono predominare scrupoli moralistici meno in linea con la ricerca della verità, come in questa stessa digressione, quando Manzoni si preoccupa che una storia ricca di descrizioni amorose, ottima per due innamorati nel giorno delle nozze, non venga invece “alle mani per esempio d’una vergine non più acerba” o non turbi la tranquillità di un giovane prete “coi gravi uficj del suo ministero”. Entrerà in tutto questo anche la consueta prudenza dell’autore. (Suitner, p.124 -5)
È il caso, a questo punto, di entrare nel testo che compare nella prima redazione e poi sparisce del tutto quando si arriva alla scrittura finale.
Allora si può comprendere che abbia fatto bene, non tanto per questioni di ordine morale, non certo perché non è rilevante neppure ai fini di una miglior considerazione del personaggio qui emergente, quanto piuttosto perché simili vicende non appaiono congruenti con la storia che si vuol seguire e quindi con l’“economia” complessiva dell’opera. In questo brano si vede il complesso tormento che sconvolge la monaca: anche il ricorso a certi suoni espressivi rivela l’efficacia dello scrittore nel rendere in modo adeguato il serpeggiare del male in quella coscienza sempre più sconvolta e che si lascia conquistare dal malvagio che l’ha ormai irretita.
Un giorno mentre le educande erano tutte congregate nella stanza del lavoro con le due suore addette ai servigi della Signora, passeggiava essa sola innanzi e indietro nel cortiletto lontana le mille miglia da ogni sospetto d’insidie, come il pettirosso sbadato saltella di ramo in ramo senza pure immaginarsi che in quella macchia vi sia dei panioni, e nascosto dietro a quella il cacciatore che gli ha disposti. Tutt’ad un tratto sentì ella venire dai tetti come un romore di voce non articolata la quale voleva farsi e non farsi intendere, e macchinalmente levò la faccia verso quella parte; e mentre andava errando con l’occhio per quegli alti e bassi, quasi cercando il punto preciso donde il romore era partito, un secondo romore simile al primo, e che manifestamente le apparve una chiamata misteriosa e cauta, le colpì l’orecchio, e la fece avvertire il punto ch’ella cercava. Guardò ella allora più fissamente per conoscere che fosse; e i cenni che vide non le lasciarono dubbio sulla intenzione di quella chiamata. Bisogna qui render giustizia a quella infelice: qual che fosse fin’allora stata la licenza dei suoi pensieri, il sentimento ch’ella provò in quel punto fu un terrore schietto e forte: chinò tosto lo sguardo, fece un cipiglio severo e sprezzante, e corse come a rifuggirsi sotto quel lato del porticato che toccava la casa del vicino, e dove per conseguenza ella era riparata dall’occhio temerario di quello: quivi tirando lunghesso il muro, rannicchiata e ristretta come se fosse inseguita, si avviò all’angolo dov’era una scaletta che conduceva alle sue stanze, vi salse, e vi si chiuse, quasi per porsi in sicuro. Posta a sedere tutta ansante, fu assalita da una folla di pensieri: cominciò prima di tutto a ripensare se mai ella a-vesse dato ansa in alcun modo alla arditezza di colui, e trovatasi innocente, si rallegrò: quindi detestando ancora sinceramente ciò che aveva veduto, se lo andava raffigurando e rimettendo nella immaginazione per venire più chiaramente a comprendere come, perché ciò fosse avvenuto. (…) Finalmente dopo lunga pezza ella si levò come stanca di tanti pensieri che finivano in uno, e desiderò di trovarsi con le sue educande, con le suore, di non esser sola.
Esitò alquanto su la strada che doveva fare: ripassando pel cortiletto, ella avrebbe potuto lanciare un guardo alla sfuggita dietro le spalle su quei tetti per vedere se colui era tanto ardito da trattenervisi, e così saper meglio come regolarsi…, ma s’accorse tosto ella stessa che questo era un sofisma della curiosità, o di qualche cosa di peggio, e senza più esitare, s’avviò pel dormitorio alla stanza dove erano le educande: qui, o fosse caso o un resto di quella esitazione ella si affacciò ad una finestra che aveva dirimpetto appunto quei tetti, vi guardò, vide il temerario che non si era mosso, partì tosto dalla finestra, la chiuse, e uscì da quella stanza dicendo in fretta alle educande con voce commossa: «lavorate da brave»; e se ne andò difilato a passeggiare nel giardino del chiostro. L’atto repentino, e la commozione della voce non diedero nulla da pensare né alle educande né alle suore, avvezze le une e le altre agli sbalzi frequenti dell’umore della Signora. Ma ella stava peggio nel giardino che già non fosse nelle sue stanze. Le venne un pensiero, che avrebbe dovuto avvertire dell’accaduto chi poteva opporsi a tanta temerità.
(Fermo e Lucia, Tomo II, Capitolo V, p. 212-214)
“La sventurata rispose”: così riassumerà poi l’autore a proposito delle insidie tese dallo scellerato, che l’aveva trascinata al male. E qui il male diventa di fatto omicidio, raccontato fino all’esito finale. Poi però, pur con il medesimo risultato nella redazione finale, questo viene fatto chiaramente intendere, senza che se ne possano vedere le singole azioni che conducono all’esito drammatico.
Una delle due suore addette alla Signora quando cominciò ad avere qualche sospetto, lo confidò ad un’altra suora sua amica, facendosi promettere il segreto: promessa che le fu tenuta perché la Signora era troppo potente, e il segreto troppo pericoloso; e la voglia di ciarlare fu vinta dalla paura. Non era che un sospetto, e gli indizj eran deboli e potevano anche essere interpretati altrimenti; ma la curiosità della suora fu risvegliata, e non lasciava mai di tempestare quella che le aveva fatta la confidenza, per vederne, come si dice, l’acqua chiara. Quando però la suora che aveva ciarlato divenne complice, si studiò non solo di eludere le inchieste della curiosa, ma di disdirsi, e di farle credere che il sospetto era ingiurioso e stolto, e ch’ella stessa si era pienamente disingannata. Ciò non ostante la curiosa ritenne sempre quel sospetto, e non lasciava sfuggire occasione di gettar gli occhi nel quartiere delle educande, e di origliare, per venire a qualche certezza.
Accadde un giorno che la Signora venuta a parole con costei la aspreggiò, e la trattò con tali termini di villania, che la suora dimenticata ogni cautela, si lasciò sfuggire dalla chiostra dei denti: ch’ella sapeva qualche cosa, e che a tempo e luogo l’avrebbe detto a cui si doveva. La Signora non ebbe più pace. Che orrenda consulta! le tre sciagurate, e il loro infernale consigliero deliberarono sul modo di imporre silenzio alla suora. Il modo fu pensato e proposto da lui con indifferenza, e acconsentito dalle altre con difficoltà, con resistenza, ma alla fine acconsentito. Geltrude fece più resistenza delle altre, protestò più volte che era pronta a tutto soffrire piuttosto che dar mano ad una tanta scelleratezza, ma finalmente vinta dalle istanze di Egidio e delle due, e nello stesso tempo dal suo terrore, venne ad una transazione con la quale ella si sforzò di fingere a se stessa che sarebbe men rea: pattuì ella dunque che non si sarebbe impacciata di nulla, ed avrebbe lasciato fare. Presi gli orribili concerti, determinato dalle esortazioni di Egidio al sangue l’animo di quella che fu scelta a versarlo; costei si ravvicinò alla suora condannata e le parlò di nuovo di quegli antichi sospetti, in modo da crescerle la curiosità. E la curiosità era stimolata in essa dal desiderio di vendicarsi della Signora; ma per farlo con sicurezza, aveva essa stessa bisogno di esser sicura. La traditrice, mostrando che non le convenisse di stare più a lungo assente dalla Signora per darle sospetto, lasciò la suora nel forte della curiosità, e nella speranza di scoprire qualche cosa; e come questa insisteva per trattenerla, le propose di venire la notte al quartiere, dove l’avrebbe potuta nascondere nella sua cella, e dirle il di più, e forse renderla testimonio di qualche cosa. La meschina cadde nel laccio. Venuta la notte ella si trovò nel corridojo, dove la suora omicida le venne incontro chetamente, e la condusse nella sua cella: quivi, preso il pretesto dei servigj della Signora per partirsi, promettendo che tornerebbe tosto; la fece nascondersi tra il letticciuolo e la mura, raccomandandole di non muoversi finch’ella non la chiamasse. Uscì quindi a render conto del fatto all’altra suora e allo scellerato che aspettavano in un’altra stanza, e pigliato da Egidio l’orribile coraggio che le abbisognava, entrò nella cella armata d’uno sgabello con la sua compagna. Nella cella non v’era lume, ma quello che ardeva nella stanza vicina vi mandava per la porta aperta una dubbia luce. La scellerata parlando con la compagna, perché la nascosta non si muovesse, e parlando in modo da farle credere ch’ella cercava di rimandare la sua compagna come importuna, andò prima pianamente verso il luogo dove la infelice stavasi rannicchiata, quindi giuntale presso le si avventò, e prima che quella potesse né difendersi né gettare un grido né quasi avvedersi, con un colpo la lasciò senza vita.
(Fermo e Lucia, Tomo II, Capitolo V, p. 217-219)
IL CONTE DEL SAGRATO
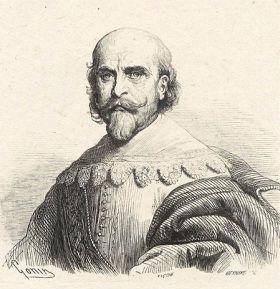 Colui che noi conosciamo con il nome di “Innominato” è da tutti e da sempre riconosciuto come il personaggio “chiave” della storia: la sua stessa abitazione sul crinale di un monte, che segna la separazione fra due Stati, lo erige, nella vicenda, come il punto di arrivo di una storia che si complica e che, grazie a lui, poi si scioglie, per condursi a buon fine. E questo, ovviamente, grazie al fatto che il personaggio, emblematico nella sua malvagità, giganteggia poi nella sua conversione, l’apice di quella storia umana, che è sempre condotta in modo provvidenziale ed è quindi nelle mani de “il Dio che atterra e suscita, / che affanna e che consola” (Il cinque maggio, vv. 105-106). Qui, più che negli altri, possiamo vedere la presenza stessa dell’autore alla storia costruita dalla sua fantasia, perché, almeno per la “conversione” di quest’uomo, che è l’episodio centrale e spartiacque della narrazione, noi possiamo intravedere qualcosa di ciò che lo stesso scrittore ha sperimentato nella sua personale vicenda di uomo, su cui non ha mai voluto dare parole di spiegazione. Egli, però, vi riconosce l’intervento della grazia divina, rappresentata dal simbolo della luce, la quale poi viene incarnata in Lucia, il personaggio centrale che conserva sempre questo nome emblematico.
Colui che noi conosciamo con il nome di “Innominato” è da tutti e da sempre riconosciuto come il personaggio “chiave” della storia: la sua stessa abitazione sul crinale di un monte, che segna la separazione fra due Stati, lo erige, nella vicenda, come il punto di arrivo di una storia che si complica e che, grazie a lui, poi si scioglie, per condursi a buon fine. E questo, ovviamente, grazie al fatto che il personaggio, emblematico nella sua malvagità, giganteggia poi nella sua conversione, l’apice di quella storia umana, che è sempre condotta in modo provvidenziale ed è quindi nelle mani de “il Dio che atterra e suscita, / che affanna e che consola” (Il cinque maggio, vv. 105-106). Qui, più che negli altri, possiamo vedere la presenza stessa dell’autore alla storia costruita dalla sua fantasia, perché, almeno per la “conversione” di quest’uomo, che è l’episodio centrale e spartiacque della narrazione, noi possiamo intravedere qualcosa di ciò che lo stesso scrittore ha sperimentato nella sua personale vicenda di uomo, su cui non ha mai voluto dare parole di spiegazione. Egli, però, vi riconosce l’intervento della grazia divina, rappresentata dal simbolo della luce, la quale poi viene incarnata in Lucia, il personaggio centrale che conserva sempre questo nome emblematico.
Cambia il nome invece questo personaggio. Di per sé non avrà mai il suo nome, quasi a farne qualcosa di più alto e misterioso per il ruolo che riveste nella vicenda. Addirittura diventa “l’Innominato”, come a voler imprimersi così, senza nome, per esser ancora di più il segno tangibile di quello stesso Dio, che egli impreca ed invoca nel momento cruciale della sua conversione davanti al cardinale. Eppure anche questa figura ha dietro di sé un personaggio storico, per quanto l’autore voglia ricrearlo come qualcuno di assolutamente nuovo, inedito, singolare. Nella redazione ultima gli rimane impresso questo nome per il quale ancora oggi è noto, nonostante il mistero che aleggia attorno a lui. Ma nella prima edizione egli compare con un nome diverso, che è pur sempre insufficiente a definirlo, perché in esso c’è solo il ricordo di uno dei suoi numerosi misfatti. E questo naturalmente viene raccontato, mentre non se ne ha traccia nella edizione finale.
L’Illuminato è il personaggio manzoniano che ha avuto le maggiori trasformazioni nell’elaborazione del Fermo e Lucia. Il nomignolo di Conte del Sagrato poteva avere qualcosa di ingenuo e di sforzato. La rinuncia a un’indicazione precisa aumentava l’alone misterioso e superumano da cui il personaggio era circondato.
Un po’ tutta la tradizione critica è concorde nel riconoscere nel Conte del Sagrato un archetipo dell’immaginazione romantica. Il Conte, e quindi anche l’Innominato seppur con qualche attenuazione, risponde al tipo dell’eroe fuorilegge, dell’uomo di attitudini eccezionali che, disgustato dal mondo, si è messo al di fuori della società ergendosi al di sopra delle leggi degli uomini e rispettando le sue sole regole. (…) … è del tutto evidente, più di quanto non accada ad esempio per Lucia o la monaca di Monza o per gli altri caratteri. Manzoni ha in questo caso letterariamente rivestito un personaggio storico la cui vicenda, nelle linee essenziali, aveva incontrato nelle opere di Ripamonti e di Rivola (prete milanese, dottore dell’Ambrosiana, vissuto fra il 1570 e il 1655). L’identità storica dell’Innominato manzoniano è sicura. Lo stesso scrittore in una lettera indirizzata a Cesare Cantù (storico originario di Brivio, vissuto fra il 1804 e il 1895), scrisse che “l’Innominato è certamente Bernardino Visconti …”. Si trattava quindi di Francesco Bernardino Visconti, feudatario di Brignano nella Ghiara d’Adda, bandito nel 1603 dal governatore di Milano dell’epoca. Manzoni si limitò a spostarne il castello e a costruire su di lui una nuova storia legata ai protagonisti del romanzo. (Suitner, p. 91)
Anche ad apparire molto simili nei modi e nelle emozioni che ne derivano, i due personaggi sono elaborati in modo molto diverso: il Conte del Sagrato appare rozzo nel suo esprimersi, facilmente infastidito, ma soprattutto molto spiccio nei suoi interventi brutali, come succede nell’episodio che lo rivela per quello che poi diventa il suo primo nome.
Abitava egli in un castello posto al confine degli stati veneti, sur un monte; e quivi menava una vita sciolta da ogni riguardo di legge, comandando a tutti gli abitatori del contorno, non riconoscendo superiore a sè, arbitro violento dei negozj altrui come di quelli nei quali era parte, raccettatore di tutti i banditi, di tutti i fuggitivi per delitti quando fossero abili a commetterne di nuovi, appaltatore di delitti per professione. «La sua casa» per servirci della descrizione che ne fa il Ripamonti «era come una officina di commessioni d’ammazzamento: servì condannati nella testa, e troncatori di teste: né cuoco né guattero dispensati dall’omicidio; le mani dei valletti insanguinate». E la confidenza di costui, nutrita dal sentimento della forza e da una lunga esperienza d’impunità era venuta a tanto, che dovendo egli un giorno passar vicino a Milano, vi entrò senza rispetto, benché capitalmente bandito, cavalcò per la città coi suoi cani, e a suon di tromba, passò sulla porta del palazzo ove abitava il governatore, e lasciò alle guardie una imbasciata di villanie da essergli riferita in suo nome.
Avvenne un giorno che a costui come a protettore noto di tutte le cause spallate si presentò un debitore svogliato di pagare, e si richiamò a lui della molestia che gli era recata dal suo creditore, raccontando il negozio a modo suo, e protestando ch’egli non doveva nulla, e che non aveva al mondo altra speranza che nella protezione onnipotente del signor Conte. Il creditore, un benestante d’un paese vicino, non era sul calendario del Conte, perché senza provocar-lo giammai, né usargli il menomo atto di disprezzo, pure mostrava di non volere stare come gli altri alla suggezione di lui, come chi vive pei fatti suoi e non ha bisogno né timore di prepotenti. Al Conte fu molto gradita l’opportunità di dare una scuola a questo signore: trovò irrepugnabili le ragioni del debitore, lo prese nella sua protezione, chiamò un servo, e gli disse: «Accompagnerai questo pover uomo dal signor tale, a cui dirai in mio nome che non gli rechi più molestia alcuna per quel debito preteso, perché io ho riconosciuto che costui non gli deve nulla: ascolterai la sua risposta: non replicherai nulla quale ch’ella sia, e quale ch’ella sia, tornerai tosto a riferirmela». Il lupo e la volpe s’avviarono tosto dal creditore, al quale il lupo espose l’imbasciata, mentre la volpe stava tutta modesta a sentire. Il creditore avrebbe volentieri fatto senza un tale intromettitore; ma punto dalla insolenza di quel procedere, animato dal sentimento della sua buona ragione, e atterrito dalla idea di comparire allora allora un vigliacco, e di perdere per sempre ogni credito; rispose ch’egli non riconosceva il signor Conte per suo giudice. Il lupo e la volpe partirono senza nulla replicare, e la risposta fu tosto riferita al Conte, il quale udendola disse: «benissimo». Il primo giorno di festa la chiesa del paese dove abitava il creditore era ancora tutta piena di popolo che assisteva agli uficj divini, che il Conte si trovava sul sagrato alla testa di una troppa di bravi. Terminati gli uficj, i più vicini alla porta uscendo i primi e guardando macchinalmente sul sagrato videro quell’esercito e quel generale, e ognun d’essi spaventato, senza ben sapere che cagione di timore potesse avere si rivolsero tutti dalla parte opposta, studiando il passo quanto si poteva senza darla a gambe. Il Conte, al primo apparire di persone sulla porta si era tolto dalla spalla l’archibugio, e lo teneva con le due mani in apparecchio di spianarlo. Al muro esteriore della chiesa stavano appoggiati in fila molti archibugj secondo l’uso di quei tempi nei quali gli uomini camminavano per lo più armati, ma non osavano entrar con armi nella chiesa, e le deponevano al di fuori senza custodia per ripigliarle all’uscita. Tanta era la fede publica in quella antica semplicità! Ma i primi che uscirono non si curarono di pigliare le armi loro in presenza di quel drappello: anche i più risoluti svignavano dritto dritto dinanzi a un pericolo oscuro, impreveduto, e che non avrebbe dato tempo a ripararsi e a porsi in difesa.
I sopravvegnenti giungevano sbadatamente sulla soglia, e si rivolgevano ciascuno al lato che gli era più comodo per uscire, ma alla vista di quell’apparato tutti si volgevano dalla parte opposta e la folla usciva come acqua da un vaso che altri tenga inclinato a sbieco, che manda un filo solo da un canto dell’apertura. Si affacciò finalmente alla porta con gli altri il creditore aspettato, e il Conte al vederlo gli spianò lo schioppo addosso, accennando nello stesso punto col movimento del capo agli altri di far largo. Lo sventurato colpito dallo spavento, si pose a fuggire dall’altro lato, e la folla non meno, ma l’archibugio del Conte lo seguiva, cercando di coglierlo separato. Quegli che gli erano più lontani s’avvidero che quell’infelice era il segno, e il suo nome fu proferito in un punto da cento bocche. Allora nacque al momento una gara fra quel misero, e la turba tutta compresa da quell’amore della vita, da quell’orrore di un pericolo impensato che occupando alla sprovveduta gli animi non lascia luogo ad alcun altro più degno pensiero. Cercava egli di ficcarsi e di perdersi nella folla, e la folla lo sfuggiva pur troppo s’allontanava da lui per ogni parte, tanto ch’egli scorrazzava solo di qua di là, in un picciolo spazio vuoto, cercando il nascondiglio il più vicino. Il Conte lo prese di mira in questo spazio, lo colse, e lo stese a terra. Tutto questo fu l’affare di un momento. La folla continuò a sbandarsi, nessuno si fermò, e il Conte senza scomporsi, ritornò per la sua via, col suo accompagnamento.
(Fermo e Lucia, Tomo II, Capitolo VII, p. 246-249)
Il ritratto dell’uomo è indubbiamente efficace: lo scrittore ci offre una fisionomia che fa paura nel suo solo apparire, anche senza che debba usare male parole. Basta la sola presenza per creare il vuoto attorno, e soprattutto per suscitare il panico, il terrore, il totale disorientamento. Questo quadro a tinte fosche non sembra affatto lasciare spazio ad un possibile ravvedimento, che invece poi si registra, se non altro perché una simile conversione è necessaria a far procedere la storia nella direzione giusta. Manzoni si rende conto che, anche a dover trattare di un uomo, che nella storia risulta essere un bandito che sparge il terrore all’intorno, poi però ai fini della sua storia, deve anche renderlo più credibile con un quadro che dia spazio in lui ad una ricerca interiore in grado di portarlo al ravvedimento. Qui invece prevale la freddezza, affiora un certo cinismo, si radica in lui quella forma di durezza di cuore che lo porta al … sadismo.
Ne vien fuori un quadro truce, come doveva essere in realtà …
… (c’è) un potente signore dalla testa calva e dalla faccia adusta che vive in un aspro e ferrigno castello, e la cui solitudine misteriosa ha qualcosa di sadiano. Del Marchese di Sade Ugo Foscolo non ardì scrivere neanche il nome. Manzoni cancellò il nome di questo personaggio (nella prima stesura era il Conte del Sagrato). Esso divenne l’Innominato. Ma senza castità, purezza, dolcezza, cioè senza Lucia … non esiste sadismo, e non esiste neanche il ravvedimento e la conversione. La crudeltà legata all’amore. E per disegnare la figura di questo Conte, uno dei più sicuri e imperturbabili scellerati che la terra abbia portato, egli non temè, il “candido” Manzoni, di utilizzare ciò che il cronista Ripamonti gli forniva di più terrificante: “La sua casa … era come un officina di commessioni d’ammazzamento: servi condannati nella testa, e troncatori di teste; né cuoco né guattero dispensati dall’omicidio, le mani dei valletti insanguinate”. La descrizione accurata delle varie fasi dell’inseguimento del “creditore” da parte del Conte sarebbe degna di apparire, tanto è ricca di movimento e d’immagini, in un film western. Crudeltà nel piacere, nell’ambizione per il potere. E dei personaggi shakespeariani quello che sembra abbia colpito di più Manzoni fu Macbeth, l’uomo straziato dalla colpa, che genera spettri (l’ombra di Banco). Macbeth è l’uomo che non soltanto uccide ma fa uccidere, e “se l’omicida ai nostri giorni, quand’anche fosse impunito, sarebbe” scrive “un oggetto d’orrore”, ben più profondo orrore egli sente per chi “senza commettere l’omicidio di propria mano ne avesse dato l’ordine e il prezzo; e tali rei, oltre le pene regali, dovrebbero temere di perdere tutte le dolcezze della comune società”. (Macchia, p. 79-80)
PERSONAGGI DA RIVEDERE
Queste figure, come altre del romanzo, rimangono nella storia che viene rifatta in maniera radicale; ma assumono una nuova fisionomia, più confacente alla finalità del racconto. Manzoni, appena dato in mano agli amici il manoscritto, si rende conto, prima ancora delle loro stesse annotazioni che è necessario metter mano ad un’opera che pur gli piace e che tuttavia è bisognosa di una revisione non indifferente. Ne va della “bellezza” stessa della storia; ma ne va anche della funzione che essa può avere nell’ambito culturale, soprattutto di una cultura che vuole essere popolare e non solo d’elite. Proprio perché i personaggi non sono eroi classici, non sono figure mitiche, ma sono presi dal popolo, al popolo stesso devono servire e come tali vanno affinati per corrispondere sempre più al senso della storia.
Ancora di più meritano attenzione e una revisione adeguata quelle figure che noi immaginiamo negative, perché costituite di male e costruite per il male. Eppure anch’esse sono parte integrante della storia umana, sono creature del mondo che appartiene a Dio, e nella loro fisionomia negativa c’è sempre spazio per un possibile cambiamento. Proprio queste figure ricevono quel rimaneggiamento che li fa diventare altro, pur continuando ad appartenere al mondo del male; tuttavia, come creature della sua fantasia, esse non appaiono più così marcate nella loro malvagità, perché esse al loro primo apparire risultano dominate dal bisogno di far emergere la loro appartenenza al mondo umano; ed anch’essi diventano strumenti nella mani della Provvidenza di un percorso che deve essere considerato salvifico. Inizia così un lavoro non indiffe-rente e soprattutto non facile, che del resto richiede parecchio tempo. Ne verrà fuori però un’opera nuova, decisamente migliore, espressione di un grande equilibrio raggiunto non senza tormenti.
Egli si trova al centro di esperienze sofferte e diverse. Sono come tanti volti, ch’egli non riesce ad accordare in una sola espressione. Vi era da una parte il convertito con la sua dura morale, e dall’altra lo scrittore, che rispetta le sue leggi, nell’invenzione di una prosa non lombarda, ma italiana, una prosa per tutti, come da tempo la Francia aveva avuto e che bisognava preparare per l’Italia. (Macchia, p. 101-102)
Sulla base del fatto che con i due personaggi qui esaminati, tanto della loro vicenda viene ridimensionato, perché molti degli episodi presenti del Fermo e Lucia spariscono totalmente nella edizione successiva, dobbiamo riconoscere che anche qui l’opera d’arte consiste pure nel “levare” ciò che è di troppo, non solo per un equilibrio di tipo quantitativo, quanto piuttosto per una migliore collocazione dei personaggi stessi nella economia della vicenda, nella quale lo scrittore, che pure dobbiamo considerare presente, lo è davvero come il creatore che dà vita, come colui che rivela di essere in grado di dominare la materia, nel dominio di se stesso. In effetti il lavoro che ne esce assume una fisionomia più luminosa, un’aria più respirabile, un parlare più vivace e lineare, e questo grazie soprattutto alle operazioni messe in campo nei confronti dei personaggi qui esaminati. Essi non sono i protagonisti della storia, ma sono di fatto decisivi perché la storia possa procedere verso un esito positivo, quello per cui la “gioia, più certa e più grande”, deriva dal passaggio dentro un turbamento, mai tale da impedire alla Provvidenza di costruire il suo disegno.
Si potrebbe dire che ogni personaggio si muove dentro questo percorso; ma questo appare ancora più evidente nelle figure in cui l’annidarsi del male non sembrerebbe lasciare spazio ad un esisto positivo. Manzoni comprende che il passaggio è possibile e che il percorso richiede un lavoro di purificazione, compreso il suo nel costruire il proprio materiale.
Il primo compito cui egli si sottopose consiste nell’attenuare l’atmosfera confusa da romanzo nero e dare alla sua opera una più rigorosa architettura che il labirinto della storia non rispettava. E perciò, più che di un’architettura, si può parlare per I Promessi Sposi, come notò Italo Calvino e prima di lui Hofmannsthal (scrittore austriaco vissuto tra il 1874 e il 1929), di un intreccio di forze. Si vide più chiaro che I Promessi Sposi erano il romanzo dei rapporti di forza. Intorno a Renzo e Lucia, innamorati e inconsapevoli rappresentanti del popolo di Lombardia, nella loro onestà e nella loro bellezza, s’intrecciano per combattersi il vero e il falso potere spirituale, la nuova e la cattiva Chiesa in lotta l’una contro l’altra. Da una parte vi sono Don Rodrigo, Don Abbondio, l’Innominato, la Monaca di Monza, dall’altra Fra Cristoforo e il Cardinale Federigo, e, come coro, in questo grande romanzo di massa, c’è il popolo minuto che ama, lavora, subisce e si ribella. Tutto è calcolato nei vari registri in una specie di modulazione infinita, ove coesistono la veloce avventura e l’infuocato destino cui è impossibile ribellarsi. Tutto poteva essere sviluppato come in un romanzo popolare, e invece tutto diventa epopea, anche se, lo abbiamo detto, un’epopea negativa. Manzoni impose a episodi che nello svolgimento del racconto avevano travalicato ogni misura, un drastico e severo silenzio. E fu un silenzio pieno di cose taciute che non spengono ma alimentano l’immaginazione, come nelle sublimi brevi parole che interrompono la narrazione della storia di Gertrude: “La sventurata rispose”.
(Macchia, p. 103-104)
Si potrebbe dire che anche a partire dai ridimensionamenti dei due personaggi qui analizzati, come pure della ricomposizione degli altri in un’architettura più armonica ed equilibrata, è emersa una storia davvero corale con una regia, quello dello scrittore, che diventa il vero protagonista, per la sua capacità di dare spazio a tutti e in modo particolare ad una vicenda che non è solo di due popolani, ma è davvero di un popolo intero. Ed è di fatto la sua gente, quella di cui si sente parte e proprio per questo il giusto interprete, che sa comunicare il senso vero della storia, sempre da scrivere e soprattutto da vivere con un protagonismo non da singoli, ma nella coralità che deriva da un forte senso sociale.
… Manzoni era sì un italiano, e in maniera meravigliosa, ma che era innanzitutto un milanese. Lo stato cittadino cui apparteneva – da secoli dominato da stranieri – e il paese dipendente dalla città, scrisse Hofmannsthal, erano la sua patria. “Una storia spesso gloriosa, spesso cupa, un popolo ben definito, attivo e saggio, un dialetto stimolante, in cui ogni umore si lascia liberamente esprimere, un territorio che partecipa della pianura e si spinge fino alle grandi catene di monti, e in esso i tre bei laghi d’Europa: è questo il campo che il suo animo abbraccia. Rendere questa unità in un’opera d’arte era il profondissimo impulso che riempiva la sua anima”. E credo che sia perfettamente vero ciò che scriveva ancora Hofmannsthal: che nell’umanità espressa nel romanzo, un’umanità di stampo antico, vecchia e giovane a un tempo, impregnata fino al midollo dello spirito della cristianità, sotto quest’aria quasi quotidiana tutta legata nel reale, mai traboccante nel sogno e nel capriccio, si perpetuasse il nobile e difficile concetto d’italianità. E con tale persuasione nel cuore Hofmannsthal parlava di questo libro come di un libro quasi indistruttibile per quanto almeno reggano le fibre stesse del nostro antichissimo popolo.
(Macchia, p. 105-106)
BIBLIOGRAFIA
Alessandro Manzoni, OPERE (a cura di Lanfranco Caretti) Mursia, 1965
Alessandro Manzoni, FERMO E LUCIA – Mondadori, 1985
Franco Suitner, I PROMESSI SPOSI, UN’IDEA DI ROMANZO – Carocci, 2012
Giovanni Macchia, MANZONI E LA VIA DEL ROMANZO-Adelphi, 1994
