INTRODUZIONE.
 PAVEL FLORENSKIJ è un religioso e un uomo di scienza, un prete e un padre di famiglia felicemente sposato, un uomo a tutto tondo e di notevole levatura spirituale, che merita di essere conosciuto per la grande passione che ha animato la sua esistenza, facendolo divenire un grande innamorato dello Spirito divino, e nello stesso tempo un raffinato ed esperto ricercatore degli elementi naturali, dentro i quali vedeva all’opera Dio Creatore. Ogni suo percorso di natura scientifica, vissuto con notevole acribia, non gli impediva affatto di scoprire e di sentire lo Spirito divino; come pure ogni sua riflessione sul mondo divino gli permetteva di valorizzare ancor di più il mondo naturale. Si potrebbe dire che non esiste campo dello scibile umano che egli non abbia cercato di accostare con perizia scientifica e nello stesso tempo con finezza di natura spirituale, perché dovunque lo sguardo della mente e del cuore si mette a scrutare, lì trova Dio e trova il meglio per l’essere umano. Anche nei momenti drammatici della sua esistenza non ha mai perso di vista questo sguardo profondo che lo ha immerso in Dio e nello stesso tempo nella natura, che lui considera la migliore espressione del divino. Anche ad essere rigoroso nelle questioni scientifiche e nelle applicazioni della tecnologia, non ha mai perso quel tipo di sensibilità, tutta interiore, che gli ha permesso di elevare la sua mente a Dio e al mondo divino che lui avverte come realtà affascinante e assolutamente necessaria al vivere dell’uomo. Anche a sentirsi travolto dagli eventi non cerca nella fuga la possibilità di sopravvivere, ma vive intensamente la sua testimonianza di fede in una serenità dav-vero sorprendente. Il suo rifugio nella preghiera e nella spiritualità non è affatto una evasione alla ricerca di quella forma di pace che lo tiene al riparo dai mali. Nella sua fede cristiana egli ritiene che la propria passione, quella che vive nelle sofferenze inferte dalla persecuzione, altro non è se non partecipazione piena al vivere di Cristo, che egli ama intensamente e che vuol servire e seguire fino in fondo. Il rifiuto dell’ateismo dominante e di una fede cieca nella scienza senza “anima umana” non si tra-sforma mai in ostilità e in una contrapposizione sterile. Anzi, la sua forte spiritualità, sempre vissuta anche nel pieno della cieca e pregiudiziale persecuzione, cresce più che mai e si rivela quanto mai vivace nei suoi scritti, soprattutto di natura filosofica e teologica, messi a disposizione dei fedeli frequentatori della chiesa, e anche di coloro che hanno a cuore la medesima cultura russa, così intrisa per lui di fede ortodossa, da espor-re, da chiarire, da rendere sempre più luminosa
PAVEL FLORENSKIJ è un religioso e un uomo di scienza, un prete e un padre di famiglia felicemente sposato, un uomo a tutto tondo e di notevole levatura spirituale, che merita di essere conosciuto per la grande passione che ha animato la sua esistenza, facendolo divenire un grande innamorato dello Spirito divino, e nello stesso tempo un raffinato ed esperto ricercatore degli elementi naturali, dentro i quali vedeva all’opera Dio Creatore. Ogni suo percorso di natura scientifica, vissuto con notevole acribia, non gli impediva affatto di scoprire e di sentire lo Spirito divino; come pure ogni sua riflessione sul mondo divino gli permetteva di valorizzare ancor di più il mondo naturale. Si potrebbe dire che non esiste campo dello scibile umano che egli non abbia cercato di accostare con perizia scientifica e nello stesso tempo con finezza di natura spirituale, perché dovunque lo sguardo della mente e del cuore si mette a scrutare, lì trova Dio e trova il meglio per l’essere umano. Anche nei momenti drammatici della sua esistenza non ha mai perso di vista questo sguardo profondo che lo ha immerso in Dio e nello stesso tempo nella natura, che lui considera la migliore espressione del divino. Anche ad essere rigoroso nelle questioni scientifiche e nelle applicazioni della tecnologia, non ha mai perso quel tipo di sensibilità, tutta interiore, che gli ha permesso di elevare la sua mente a Dio e al mondo divino che lui avverte come realtà affascinante e assolutamente necessaria al vivere dell’uomo. Anche a sentirsi travolto dagli eventi non cerca nella fuga la possibilità di sopravvivere, ma vive intensamente la sua testimonianza di fede in una serenità dav-vero sorprendente. Il suo rifugio nella preghiera e nella spiritualità non è affatto una evasione alla ricerca di quella forma di pace che lo tiene al riparo dai mali. Nella sua fede cristiana egli ritiene che la propria passione, quella che vive nelle sofferenze inferte dalla persecuzione, altro non è se non partecipazione piena al vivere di Cristo, che egli ama intensamente e che vuol servire e seguire fino in fondo. Il rifiuto dell’ateismo dominante e di una fede cieca nella scienza senza “anima umana” non si tra-sforma mai in ostilità e in una contrapposizione sterile. Anzi, la sua forte spiritualità, sempre vissuta anche nel pieno della cieca e pregiudiziale persecuzione, cresce più che mai e si rivela quanto mai vivace nei suoi scritti, soprattutto di natura filosofica e teologica, messi a disposizione dei fedeli frequentatori della chiesa, e anche di coloro che hanno a cuore la medesima cultura russa, così intrisa per lui di fede ortodossa, da espor-re, da chiarire, da rendere sempre più luminosa
La cultura in Russia non può prescindere affatto dalla sua immersione nella fede religiosa, che ha sempre accompagnato il corso della storia del popolo russo.
La cultura è la lotta consapevole contro l’appiattimento generale; la cultura consiste nel distacco, quale resistenza al processo di livellamento dell’universo, è l’accrescersi della diversità di potenziale in ogni campo che assurge a condizione di vita, è la contrapposizione all’omologazione, sinonimo di morte. Ogni cultura è un sistema finalizzato e saldo di mezzi atti alla realizzazione e al disvelamento di un valore, adottato come fondamentale e assoluto e dunque fatto assurgere a oggetto di fede. I primi riflessi di questa fede nelle funzioni imprescindibili dell’uomo determinano i punti di vista sui settori inerenti a dette funzioni, ossia sulla realtà oggettiva nella sua interazione con l’uomo. Tali punti di vista sono, sì, categorie, ma non categorie astratte, bensì concrete (si veda la Kabbalah); la loro manifestazione nella pratica è il culto. La cultura, come risulta chiaro anche dall’etimologia, è un derivato dal culto, ossia un ordinamento del mondo secondo le categorie del culto. La fede determina il culto e il culto la concezione del mondo, da cui deriva la cultura. (Il simbolo e la forma in BeL, p. XXVI-XXVII)
LA SUA VICENDA UMANA Leggi tutto “Figure del mondo spirituale russo: Pavel Alexandrovich Florenskij”

 rto e alimenta la speranza: la separazione è solo temporanea.
rto e alimenta la speranza: la separazione è solo temporanea. A due anni dalla scomparsa del prof Maurizio Benedetti, Don Ivano scrive:
A due anni dalla scomparsa del prof Maurizio Benedetti, Don Ivano scrive: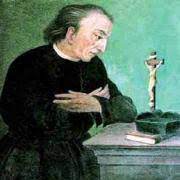 “
“ La storia narrata nel romanzo di Albert Camus è di pura invenzione, anche a trovare come sua scena la città algerina di Orano e un anno imprecisato, ma comunque appartenente alla quinta decina del secolo scorso. “
La storia narrata nel romanzo di Albert Camus è di pura invenzione, anche a trovare come sua scena la città algerina di Orano e un anno imprecisato, ma comunque appartenente alla quinta decina del secolo scorso. “